
(LaPresse)
Medio oriente
L'ambizione di Erbil, che vuole essere come Dubai
La città del Kurdistan iracheno costruisce grattacieli e mangia caviale. Ma viene risucchiata dalle sue faide interne, da quelle con Baghdad e dall’influenza iraniana
Per chi ci approda per la prima volta con l’ambizione di combinare un affare, Erbil ha tutta l’aria di una città che intende mantenere le promesse. Appena fuori dall’aeroporto internazionale, dotato di Vip lounge e caffetterie che offrono croissant e cappuccini accanto a specialità mediorientali come lahmajoon e manaqish zaatar, già si indovinano le sagome dei grattacieli con i vetri cangianti e le gru che fanno capolino dappertutto come punti esclamativi. “Il meglio dell’oriente ed il meglio dell’occidente”, garantiscono i cartelli che pubblicizzano i nuovi colossali centri commerciali, ma rispetto a Sulaymaniyah, il secondo cuore della vita politica e culturale del Kurdistan iracheno, Erbil ha un carattere più cosmopolita e un’anima decisamente più filo occidentale. Le insegne luminose dei fast food, le birrerie, le palestre, i sushi-bar rimandano ai nomi che si trovano ad Amsterdam e a Lisbona e i nuovi quartieri con le residenze più appetibili della città si chiamano Empire, Dream City, English Village, Spanish Village, Italian Village.
“Erbil ricorda la Dubai del 2004 in una versione più naif”, dice al Foglio un imprenditore iraniano. Può ancora accadere che ai confini della città, tribù rivali imbraccino un kalashnikov per uno sconfinamento o per la deviazione di un corso d’acqua, e con la stessa facilità, a Erbil accade pure che si realizzino piani che altrove richiederebbero decenni. “Nel complesso Pavillion by Rams il prezzo base di un appartamento è di tre milioni di dollari e riescono a piazzarne tre o quattro a settimana; persino una villa da 10 milioni di dollari è stata comprata dopo sette giorni, e questo in una città in cui le case generalmente costano dai 40 ai 70 mila dollari”. La gran parte di questi progetti è più o meno direttamente legata al Partito democratico del Kurdistan (Kdp) e al clan dei Barzani e questo è essenzialmente il motivo della velocità e dell’efficienza, anche se, a Erbil, la sensazione è che nessuno tema più di tanto le reazioni dell’opinione pubblica. “Messa a paragone con Teheran, dove questo genere di operazioni riconducono a pasdaran e ayatollah attraverso una babele di mediatori e prestanome, qui è tutto sfacciato, non c’è bisogno di sussurrare”. Sfacciato è un eufemismo, puntualizza con il Foglio un altro imprenditore iraniano in trasferta. “In Kurdistan circolano un sacco di soldi. Sono arrivato con l’idea di vendere trota affumicata, mi hanno risposto: l’accordo si fa, ma fanculo la trota, noi vogliamo il caviale!”.
Dubai era effettivamente il modello da seguire o piuttosto da inseguire negli anni del post Saddam, quando Erbil è diventata la capitale e insieme il motore della regione autonoma del Kurdistan, e in città con i migranti economici dell’Asia meridionale e i rifugiati delle altre martoriate province irachene, sono approdati, a ondate, anche curdi provenienti dalla Siria, dall’Iran e dalla Turchia. Nel corso di un decennio, a partire dal 2003, la popolazione di Erbil è raddoppiata e, di pari passo all’arrivo dei nuovi abitanti, sono spuntati i manager delle compagnie petrolifere e i costruttori, e in un lasso di tempo relativamente breve, si sono via via palesati l’aeroporto internazionale, le ong, i consolati, i grandi alberghi, le piscine, i locali notturni, le concessionarie di automobili, le scuole internazionali e i complessi residenziali à la page che hanno rimodellato la città inglobando la brulla pianura circostante.
Per le sue dimensioni (conta circa un milione e mezzo di abitanti), Erbil è una città che culla grandi aspirazioni. Da un lato periferia rispetto a Baghdad e dall’altro centralissimo ricettacolo delle rivendicazioni indipendentiste curde, la città ha saputo sfruttare la posizione strategica e la ricchezza di idrocarburi della regione, per attirare frotte di investitori. Ma per capire Erbil e la sua caparbia ricerca di successo, bisogna prima fare un passo indietro dentro la sua storia. Perché del suo passato che la annovera tra i centri continuamente abitati più antichi del mondo, Erbil va orgogliosissima. Di qui, oltre ai curdi e ai medi, che dei curdi sono i più probabili antenati, sono passati anche i sumeri, gli assiri, i persiani, i babilonesi, i sassanidi, i mongoli, i greci, i parti, gli arabi e gli ottomani e tutti hanno lasciato tracce più o meno visibili nell’antica fortezza, e fin sotto, tra gli strati di sedimenti che nei secoli hanno innalzato la collinetta, che adesso siede come una tiara sopra alla testa della città. Ma a dire il vero, fino a poco più di un secolo fa, al tempo in cui l’Iraq era sotto gli Ottomani, Erbil era in gran parte popolata da turkmeni, all’epoca i curdi che si trasferivano a Erbil lasciando i villaggi circostanti parlavano perlopiù turco, e molti, a forza di non praticarla, avevano dimenticato la lingua madre. E’ stato solo a partire dal decennio delle rivolte che va dal 1960 al 1970 che il carattere curdo di Erbil è diventato dominante. Oggi in cima all’antica cittadella sventola la curdissima bandiera rossa, bianca e verde con l’emblema del sole, le immagini dei combattenti peshmerga tappezzano i muri dei caffè, le strade portano i nomi di uomini come Mustafa Barzani, fondatore della dinastia che domina la vita non solo politica di Erbil e di Salahaddin, il valoroso condottiero di origine curda, noto alle cronache cristiane come il “feroce Saladino”, e in queste stesse strade, così come nelle piazze dove zampillano le nuove fontane, le statue onorano altri curdi eccellenti, come la fotografa e linguista Giwi Mukryani, o l’eroe della lotta contro il mandato britannico, Sheikh Mahmoud Barzanji.
E tuttavia, nonostante tutti gli sforzi profusi per rafforzare il senso di “curditudine” e scrollarsi di dosso la lunga ombra araba di Baghdad, il rapporto con il suo governo federale resta un nervo scoperto. Nell’agosto del 2007 l’amministrazione regionale di Erbil adotta una legge che le attribuisce il potere di negoziare contratti petroliferi unilateralmente. Da questa disposizione scaturiscono accordi con ExxonMobil, Chevron, Gazprom, Neft e Total e il Kurdistan iracheno emerge sulla scena internazionale come un interlocutore indipendente. Proprio nel 2007 la Francia apre il suo consolato, e tra il 2010 e il 2012, seguono lo stesso iter Turchia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Italia, Germania e Regno Unito. A Erbil, questi sono gli anni del boom, gli anni in cui si comincia davvero a sognare di diventare una seconda Dubai. Perché arrivano gli investimenti, si inizia a respirare il benessere, e a dispetto dei contraccolpi derivanti dalle ruggini tra il clan dei Barzani e quello dei Talabani (i primi comandano a Erbil e più in generale nella porzione occidentale del Kurdistan; i secondi a Sulamaniyah e in quella orientale), è evidente che le aspirazioni autonomiste del governo regionale di Erbil passano attraverso l’emancipazione economica da Baghdad, e in sintesi, finché c’è da crescere, tutti vogliono un pezzo della torta.
Nel 2013 con il completamento dell’oleodotto che collega Kirkuk al porto turco di Ceyhan, il governo regionale curdo, pur limitato da una serie di problemi logistici, aumenta in modo significativo la produzione di petrolio e conferma il suo status di potere economico alternativo a discapito di Baghdad. Ma la prima grave battuta d’arresto si presenta poco dopo, quando inizia a dilagare lo Stato islamico: a questo punto, a Erbil, le gru si stagliano contro il cielo come scheletri e mentre più di 100 mila sfollati si riversano in città, inclusi gli yazidi in fuga dagli eccidi del Sinjar, Dubai pare più irraggiungibile di Marte. E’ un periodo durissimo, i tagliagole dello Stato islamico arrivano a 40 chilometri dall’antica cittadella, ma i peshmerga garantiscono la sicurezza della capitale curda e strappano allo Stato islamico il controllo della regione petrolifera di Kirkuk. Nel frattempo, il governo regionale intensifica i rapporti diplomatici con la comunità internazionale, coopera con gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania e si propone sempre di più come un’entità autonoma che ambisce alla sovranità.
Il 25 settembre del 2017, Erbil forza la mano e tenta la via del referendum. La consultazione sull’indipendenza da Baghdad ha esito positivo, il 92,73 per cento approva, ma il governo iracheno rifiuta di riconoscere il risultato del voto e anche Washington e Ankara prendono le distanze. Di fatto il referendum, più che aggiungere toglie, perché i rapporti con Baghdad si complicano, e puntualmente, quando accade, si riacutizzano pure le faglie nelle relazioni intra-curde.
Nei confronti del governo federale, i due partiti principali, il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) dei Barzani e l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk) dei Talabani, si sono spesso scambiati i ruoli, alternando dialogo e chiusura. Semplificando un po’, fino al 2003 è stato il Kdp il più aperto alla cooperazione ed il Puk il più renitente. Ma la cacciata di Saddam ha rovesciato questo paradigma. Non è un mistero che il Puk, al contrario del Kdp, guardi con favore a Teheran, che a Erbil il sostegno americano venga considerato imprescindibile e che, di converso, a Sulamaniyah, il ribilanciamento dei Barzani a vantaggio dei Talabani non possa che fondarsi sui buoni uffici iraniani. C’è poi da tenere conto che in parallelo, mentre a Baghdad l’ascesa degli sciiti, dei loro partiti e delle diverse fazioni armate rimescolava le carte marginalizzando gli esponenti curdi nel governo centrale, in Kurdistan si affacciava una nuova generazione di Barzani e di Talabani altrettanto ambiziosa, ma più spavalda, poco incline al pragmatismo e insofferente all’idea del sacrificio.
Ciò detto negli ultimi vent’anni, gran parte dei problemi tra Erbil e Baghdad sono da imputare alla Costituzione del 2005 e alla sua ambiguità nel delineare le prerogative del governo centrale e di quello regionale per ciò che concerne la distribuzione, l’esportazione e lo sfruttamento dei proventi degli idrocarburi. In particolare, secondo i curdi, dagli articoli 110, 111 e 112 si evince che il governo centrale non può accampare pretese sulle riserve scoperte dopo la ratifica della costituzione, riserve perlopiù situate in aeree sotto il controllo del governo regionale curdo. E su questa base, nonostante le proteste di Baghdad, Erbil ha stretto gli accordi bilaterali con le società petrolifere che hanno fatto volare la sua economia e le hanno consentito di resistere prima allo Stato islamico e poi al Covid. Ma negli ultimi anni i rapporti di forza con Baghdad sono mutati e non nel senso che avrebbe auspicato Erbil. Il governo centrale ha ripreso il controllo di Kirkuk, i suoi uomini pattugliano le frontiere curde (si sono piazzati anche dentro i nuovi aeroporti), nel 2022 la Corte suprema irachena ha sposato la sua posizione in merito all’annosa disputa sulla Costituzione e nel 2023 la sentenza di un tribunale arbitrale internazionale ha fermato le esportazioni di petrolio attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, il che, per il sogno indipendentista curdo, equivale se non a una pietra tombale, a qualcosa che, almeno per il momento, le somiglia.
Con le casse vuote, Erbil ha iniziato a dipendere dalle elargizioni di Baghdad per mandare avanti la sua macchina amministrativa, e se il suo governo congela i fondi o li concede a singhiozzo, come è accaduto quest’anno, in città il termometro dell’insoddisfazione schizza alle stelle. Perché a Erbil la penuria d’acqua e di elettricità è cronica, nei supermercati la maggior parte dei prodotti è iraniana e turca e la forbice tra ricchi e poveri si va allargando: chi abita in complessi residenziali come il Pavillion passeggia tuffando le dita dentro specchi d’acqua artificiali, chi vive in quartieri meno fortunati come Kasnazan o Taajil si tappa il naso attraversando vicoli in cui scorrono i liquami delle fogne. In certe zone della città le gru sono in piena attività, perché nonostante la complessa congiuntura economica si continua a costruire. (Seguitano a girare molti soldi a Erbil, visto che il petrolio che non può più prendere la via dell’oleodotto viene venduto al mercato nero, ingrossando le tasche “degli amici degli amici” dei Barzani e dei Talabani). E’ l’immobiliare a mangiarsi il 30 per cento di tutti gli investimenti, altri settori vitali come l’agricoltura, la sanità, le scuole e il sistema bancario ricevono all’incirca il 6 per cento e il sogno di trasformare Erbil in un nuova Dubai pare essersi incagliato nell’incapacità di elaborare un’idea di sviluppo equa e sostenibile.
Nel frattempo, a maggio Erbil ha siglato nuovi accordi per lo sfruttamento dei suoi giacimenti di gas con le società statunitensi HKN Energy e WesternZagros, (accordi che valgono oltre 100 miliardi di dollari) e dopo due anni di stallo, il governo federale iracheno e l’amministrazione autonoma del Kurdistan hanno raggiunto un’intesa per riprendere le esportazioni di petrolio verso la Turchia. Riapre l’oleodotto, è una buona notizia, ma quella di Erbil è stata un’estate inquieta, tormentata dall’eco delle bombe su Teheran e dalla paura del contagio, un’estate funestata da una pioggia di droni contro i giacimenti curdi (droni che secondo le autorità curde sono stati lanciati dalle milizie sciite filoiraniane di Baghdad), un’estate violenta (si sono succeduti rapimenti e omicidi non solo tra clan rivali, ma anche nel seno delle stesse famiglie politiche), un’estate torrida in cui le promesse non sono mai sembrate più vuote (mai più generatori, mai più rubinetti a secco, ha assicurato il primo ministro Masrour Barzani), un’estate in cui il famoso “momento curdo” che pareva inevitabile è di nuovo tornato una chimera.
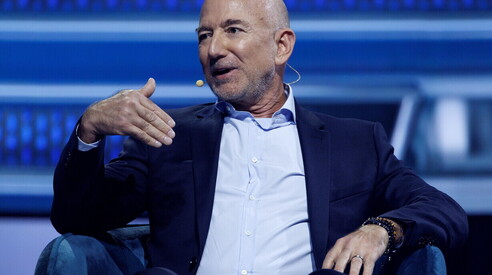

tra stati uniti e italia
J. D. Vannacci: vite politiche parallele dei vice di Trump e Salvini






