
Foto LaPresse
italia-turchia
Fidan a Roma. Il ministro turco vede Tajani. Sul dossier libico, non c'è accordo. Il ruolo di Haftar
Il capo della diplomazia turca è in visita a Roma per affrontare con l’omologo italiano temi cruciali, tra cui la crisi libica, dove restano divergenze. Ankara punta a rafforzare il proprio peso nell’area, dialogando sia con Tripoli sia con Bengasi, in un delicato gioco di equilibrio regionale
Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, arriva oggi a Roma per incontrare Antonio Tajani e dare un seguito ai tanti dossier congiunti che riguardano Italia e Turchia. Alleati e competitor a un tempo, i due ministri hanno già sancito un’intesa che è culminata, lo scorso aprile, con una decina di accordi bilaterali, primo fra tutti quello tra Leonardo e Baykar sui droni. Si parlerà di tante crisi internazionali, dall’Ucraina all’immigrazione, ma in cima alle discussioni ci sarà la questione libica. Da tempo, i due paesi si ritrovano a collaborare sul dossieri, come dimostrato dall’incontro trilaterale Meloni-Erdogan-Dabaiba a Istanbul, ad agosto. L’Italia è tenuta in ostaggio della questione migratoria e soffre di una influenza economica sempre più indebolita. Nel tempo la Turchia è stata invece capace di imporsi come partner strategico di Tripoli, estendendo la sua influenza ormai anche alla Cirenaica, zona orientale della Libia sotto il controllo del generale Khalifa Haftar. Entro fine mese, l’uomo forte dell’est dovrebbe andare in visita ufficiale ad Ankara, rispondendo all’invito di Ibrahim Kalin, il direttore del servizio di intelligence turco Mit. A fine agosto, Kalin si è recato a Bengasi e una fregata turca ha fatto scalo nel porto della città senza passare da Tripoli, sancendo così l’inizio di una nuova fase che vede Ankara consolidare la propria influenza sull’intero paese.
Nel 2019, l’intervento della Turchia a fianco del governo di unità nazionale (Gnu) di Tripoli ha giocato un ruolo cruciale nel rompere l’assedio imposto da Haftar alla capitale. Forti del contributo, i turchi hanno ottenuto dal governo, allora guidato da Fayez al Sarraj, la firma di un accordo marittimo che definisce un’ampia zona economica esclusiva nel Mediterraneo orientale. Un fronte composto da Grecia, Cipro ed Egitto si oppone da anni al trattato, rivendicando la sovranità su quei tratti di mare. La questione coinvolge anche gli interessi europei. Il gasdotto EastMed, che collega i giacimenti israeliani all’Europa attraverso la Grecia, passa esattamente da quelle acque. Sulla mappa però la proiezione del corridoio tra Ankara e Tripoli parte dalla zona orientale della Libia, quella controllata da Haftar, che fino a questo momento si è opposto alla ratifica dell’accordo. Negli ultimi anni il panorama libico ha assistito a un parziale rimescolamento delle alleanze esterne e delle dinamiche di influenza, ma Haftar è rimasto nelle mani degli Emirati Arabi Uniti, che usano le basi dell’est come ponte verso il Sudan, dell’Egitto e della Russia, radicata con basi e uomini.
“E’ significativo che la Turchia sia riuscita a costruire un dialogo con la fazione di Haftar e il governo di Bengasi senza rinunciare al sostegno garantito a Tripoli. Si tratta di un delicato esercizio di bilanciamento, che dimostra un forte senso di pragmatismo”, racconta al Foglio Ozgur Unluhisarcikli, direttore dell’ufficio di Ankara del German Marshall Fund of the United States. Ma i rapporti vanno oltre il trattato sulle acque territoriali. A giugno, è stato firmato un accordo di cooperazione tra la Turkish Petroleum (Tpao) e la National Oil Company libica per la conduzione di attività di esplorazione offshore, mentre numerosi contratti legano i due paesi nei campi di difesa, sicurezza e infrastrutture, continua Unluhisarcikli. A differenza di altri attori, Italia compresa, la Turchia ha saputo sfruttare con abilità diplomatica e militare il pantano libico, arrivando a controllare una parte rilevante del processo decisionale del paese. L’obiettivo dei turchi è evidente: utilizzare l’influenza sulla Libia, e il suo posizionamento strategico, come leva negoziale, imponendo agli attori regionali il coinvolgimento di Ankara ai principali tavoli decisionali. Un modo per affermare che nel Mediterraneo, nessun equilibrio può prescindere dalla Turchia.
“Tuttavia, anche se la possibile ratifica del memorandum da parte del Parlamento di Bengasi rafforzerebbe la posizione turca sulla partita del Mediterraneo orientale, questa non risolverà la disputa giuridica alla base della questione – prosegue Unluhisarcikli – La Grecia lo considera una violazione della Convenzione Unclos, che regola la legge del mare, a cui la Turchia ribadisce di non essere vincolata non avendola mai sottoscritta”. Sia Atene sia Ankara adottano approcci massimalisti, rendendo difficile trovare un punto d’incontro e, in assenza di un’intesa più ampia, lo status quo nella regione resterà sostanzialmente immutato, conclude Unluhisarcikli. Con la ratifica del trattato da parte di Haftar, le argomentazioni della Turchia saranno però certamente più coerenti. Inoltre, rispetto all’indomani delle primavere arabe, quando il sostegno ai movimenti popolari costò alla Turchia l’isolamento regionale, oggi Ankara può vantare solidi rapporti con il mondo arabo, Egitto compreso.
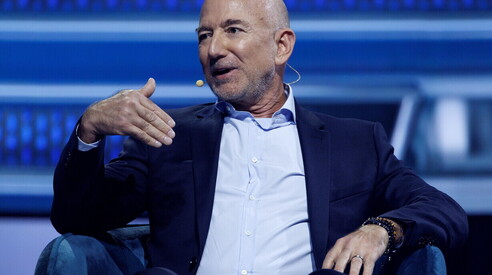

tra stati uniti e italia
J. D. Vannacci: vite politiche parallele dei vice di Trump e Salvini



