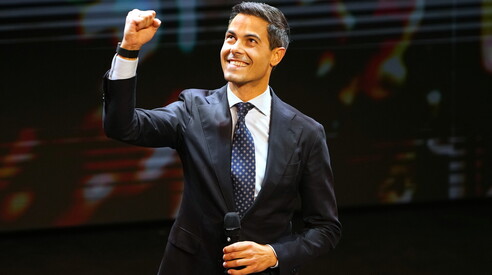Foto Ansa
negli Stati Uniti
Tenere insieme le bandiere e la polvere. Il caso Smithsonian
Il presidente Trump accusa l'istituto di raccontare una storia troppo critica dell’America e cerca di imporre una svolta patriottica. Ma il vero compito della storia è mantenere uniti gloria e vergogna
La passione per i musei non è tra le doti più spiccate di Trump. Eppure, forse perché ce l’ha vicino, il presidente si è improvvisamente ricordato dello Smithsonian, il grande complesso di Washington, accusandolo di ricostruire la storia dell’America in modo wokista: troppa schiavitù e razzismo, tante ombre e nessuna luce, così il pubblico finisce per deprimersi e dimentica quanto il paese è stato forte e bello. Va da sé che la Casa Bianca ha intimato un riallestimento delle sale e una riformulazione dei testi d’accompagnamento, perché la visita abbia un effetto rinvigorente e patriottico. Dallo Smithsonian hanno replicato che la loro bussola rimane l’integrità intellettuale e continueranno a lavorare “per aiutare la nazione a comprendere il proprio passato”. Trump e lo staff del museo forse non lo sanno, ma incarnano le due funzioni che Nietzsche assegna a una storia che vuole essere utile alla vita. Quella monumentale offre modelli di grandeur, si mette in caccia di maestri e consolatori, e corrobora l’azione, ma c’è anche una storia critica, che giudica e condanna ciò che “merita la fine”, tenendo davanti allo sguardo “quanto sia ingiusta l’esistenza di un privilegio, di una casta”.
Le due tendenze, per quanto divergenti, non sono necessariamente rivali. Anzi, è meglio se cooperano: la prima galvanizza, la seconda libera. In molti casi, e sono quelli davvero interessanti, il confine tra ciò che va monumentalizzato e ciò che va criticato sfuma. Lo scrittore più nicciano d’America, William Faulkner, pensava che il fiore più nobile del suo paese fosse stato l’esercito confederato, “un esercito di gentiluomini, dove fante e colonnello si chiamavano a vicenda per nome, non come un contadino chiama un altro contadino di qua da un aratro fermato nel campo, o di qua da un banco in un negozio carico di tela e formaggio e olio da corregge, ma come un uomo ne chiama un altro di sopra le dolci spalle incipriate delle donne, di sopra i due calici levati di chiaretto di moscato o champagne”. Ma, discendente di una famiglia schiavista, sapeva di che lacrime e sangue grondasse quella irripetibile e aristocratica umanità.
“Il passato non è mai morto, e non è nemmeno passato”, perché non smette di entusiasmarci e angosciarci, stringendo sul presente un nodo di eroismo e vergogna. Lo studio attento della storia mette davanti alla logica tragica per cui fiori e sangue, dèi superni e Acheronte, si presentano fianco a fianco sulla stessa scena. Le fanfaronate di Trump, con il suo calvinismo ateo che manca di fede in tutto tranne nel successo, sono il contrappunto alla querula voce dei wokisti: l’uno e gli altri vedono una cosa sola dove la realtà è doppia. Se la storia monumentale si priva della critica, scade a estetica di partito; invece, la critica senza la monumentalità produce il risentimento. Né propaganda né autoflagellazione, il compito di un museo è tenere insieme le bandiere e la polvere. Soltanto così la storia serve la vita.