
(foto Ansa)
l'analisi
L'ultima spiaggia dei populismi. Tre idee per trasformare le gare da obbligo giuridico in opportunità di sviluppo
Fuga dagli stabilimenti balneari, accusati di alzare i prezzi. Il motivo è anche l’assenza di regole precise sulle concessioni. Ecco come riportare gli italiani al mare
Giorgia Meloni ha due scelte: o continuare a nascondersi dietro l’ombrellone, come i bambini che non vedendo credono di non essere visti, oppure prenderlo e decidere dove piantarlo. Le polemiche sui prezzi delle sdraio e sulla scarsità degli arenili ad agosto sono puntuali come il sole a mezzogiorno. Quest’anno ad agitare le acque è stato il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, secondo cui uno stabilimento del casertano avrebbe vietato a una donna di portare cibo in spiaggia (il titolare sostiene invece che la richiesta era di consumare il pasto nei tavolini appositi e non sulla sdraio). Intanto a Jesolo si polemizza per il poco spazio adibito a spiaggia libera, mentre altrove – come in Salento e in Romagna – c’è chi lamenta il basso afflusso turistico. Le singole vicende dicono poco di un settore sul quale, ormai da due decenni, sventola la bandiera rossa di ripetute infrazioni europee. Per comprendere meglio, è necessario mettere un poco di distanza rispetto al rumore di fondo e all’aneddotica: bisogna andare alla radice. La mappatura degli arenili conclusa nel 2023 – un tentativo di vestire di formalità e pseudoevidenza una decisione già presa – dice che solo il 33 per cento delle coste italiane è occupato da stabilimenti. Ma, come osserva Legambiente, “il calcolo è stato effettuato sul totale della costa italiana e non sulle sole aree balneabili e di costa bassa, includendo quindi anche i tratti di costa rocciosa, quelli non accessibili, le spiagge non appetibili per motivi oggettivi o quelle che non possono essere date in concessione perché sono presenti infrastrutture e manufatti”. In alcune regioni, come Liguria, Emilia-Romagna e Campania, il litorale sarebbe occupato in percentuali prossime al 70 per cento. In questo contesto caotico, la latitanza del governo lascia il campo libero ai ricorsi e alla magistratura, che puntualmente ribadisce l’obbligo delle gare. Ma l’assenza di un quadro normativo di riferimento fa ulteriormente crescere l’entropia attorno a queste ultime. La politica dovrebbe sforzarsi di indirizzare il processo, disegnando meccanismi uniformi sul territorio nazionale, non punitivi nei confronti dei gestori uscenti ma neppure orientati a un rinnovo semiautomatico delle concessioni esistenti.
Per farlo è necessario mettere a fuoco i reali obiettivi che si intende perseguire. In primo luogo, occorre intervenire sulla destinazione dei canoni. Una delle ragioni per cui i comuni vivono con scarsa partecipazione questa battaglia è che, pur essendo i terminali di qualunque lamentela, non hanno alcun interesse allo svolgimento delle gare. Una riforma essenziale, quindi, consiste nel prevedere che una parte congrua del canone (magari la quota eccedente i livelli attuali) sia destinata ai comuni. Ciò risponde anche all’esigenza di compensare la collettività, e in particolare i residenti che non traggono vantaggio dalle presenze turistiche, per le esternalità che inevitabilmente esse causano (congestione, prezzi immobiliari, eccetera). Un secondo tema riguarda la valorizzazione della componente qualitativa delle offerte presentate in sede di gara: essa dovrebbe essere usata per promuovere investimenti e servizi, in modo che l’offerta balneare diventi parte integrante (e non quasi parassitaria) dello sviluppo del territorio. Le pretese economiche eccessive, che oggi alcuni considerano responsabili del calo registrato in alcune zone, mostrano che c’è un limite a quello che i turisti sono disposti a pagare per la sdraio: senza uno sforzo di miglioramento qualitativo e il contenimento dei prezzi si rischia di perdere la gallina dalle uova d’oro. Ciò richiede inevitabilmente idee nuove e, potenzialmente, nuovi operatori: per questo la messa in discussione delle concessioni attuali non può che giovare al settore. Un terzo tema è, infine, relativo alla determinazione dei valori di subentro, cioè dell’indennizzo che l’eventuale vincitore deve corrispondere al gestore uscente. La Commissione Ue e il Consiglio di stato hanno mosso rilievi alla bozza di decreto ministeriale predisposto dal governo, et pour cause. Se tale valore è troppo alto, di fatto impedisce la partecipazione alle gare; in caso contrario, arreca un ingiusto danno agli uscenti. Come in altri settori analoghi, dovrebbe invece riflettere gli investimenti effettivamente sostenuti, strettamente correlati alle attività caratteristiche e non ancora recuperati. Ma perché questo accada è necessario stabilire dei criteri tecnici di riferimento.
Se il governo avesse la forza di incalzare i gestori e disegnare procedure eque, potrebbe trasformare le gare da obbligo giuridico in opportunità di sviluppo. Ma questo richiede la forza di distanziarsi dalle logiche corporative che, finora, hanno determinato un fallimento collettivo lungo vent’anni.
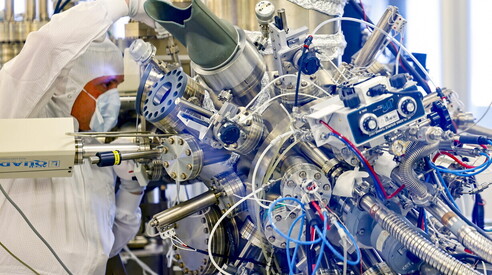


lottizzazione e lauree


