
Giovanni Morabito, Progetto per un’Unità ospedaliera a Taurianova, 1974
Biografie
Tre architetti e un lutto unito. Le storie di Morabito, Stern e Prati
Erano praticamente coetanei e, per quanto diversi per estrazione e per carattere, tutti legati alla stagione dell’architettura disegnata. Un ricordo
La morte, ieri, ha accomunato tre architetti praticamente coetanei che, per quanto diversi per estrazione e per carattere, erano tutti legati alla stagione dell’architettura disegnata. Giovanni Morabito – per tutti Nanni - era nato a Palmi, in Calabria, nel 1938, paese di Leonida Repaci, e dopo il liceo affrontato con Nino Marazzitta come compagno di banco, si era iscritto nella migliore facoltà di ingegneria italiana dell’epoca, quella di Napoli, dove si laureò nel 1962 stringendo amicizia con Angelo Di Tommaso, autore del manuale di statica fra i più diffusi. Dopo un master a Londra con il guru Zygmunt Makowski e varie avventure professionali a Firenze, si è stabilito a Roma associandosi allo studio di Costantino Dardi che proveniva da Venezia: un sodalizio non lungo, ma che lasciò il segno nell’uso della geometria lecorbusieriana dalle lunghe ombre come matrice progettuale in molti progetti di allora come le due ville estive a Palmi o i licei di Locri e Taurianova e poi successivi, ad esempio i progetti sviluppati a Pesaro sotto l’egida di Carlo Aymonino che era stato mentore dello stesso Dardi.
Vulcanico e simpaticissimo, Morabito non è mai stato comunista come loro, bensì socialista come Giacomo Mancini e tanti altri – troppo spesso infatti ci si dimentica che le giunte rosse non potevano stare in piedi senza PSI. Perciò nel 1970 si prese la laurea anche in architettura con relatore Carlo Scarpa, che era stato socialista anche lui, all’IUAV dove pure insegnò tecnologia per poi passare alle facoltà di Reggio Calabria e infine La Sapienza. Il suo insegnamento non è mai stato tecnocratico ma scientificamente erudito, pronto a integrare la tecnica al progetto e viceversa, nonostante i pressanti condizionamenti industriali e ambientali tema di cui è stato un pioniere. Dopodiché ha costruito ospedali e viadotti, restaurato la casa di Rossini a Pesaro e poi chiese, castelli, mercati in tutta Italia, rifugiandosi d’estate alla “Contura”, casa fra gli ulivi della Costa Viola, dove insieme con la moglie Valeria Vocaturo ospitavano tanti amici come Massimo Dolcini o Mario Marenco, applicando le sue tecniche alla cucina mediterranea cioè il contrario del significato di murābiṭ - eremita astemio.
Nacque invece a Flatbush, Brooklyn, nel 1939 Robert Arthur Morton Stern, da una famiglia ebraica caduta in disgrazia costringendo al madre ad andare a lavorare in un grande magazzino per crescere il piccolo Bob. La sua passione per l’architettura newyorchese a cavallo tra ‘800 e ‘900 nacque allora. Dall’aria furbetta fin da piccolo, fu rifiutato da Harvard ma riuscì comunque a studiare a Columbia e infine a Yale di cui in seguito sarà a lungo direttore, incontrando grandi personalità come Vincent Scully, Paul Rudolph e soprattutto Philip Johnson, il re di Manhattan. Una magnifica foto ritrae il venticinquenne Stern, unico etero non wasp, in compagnia di Andy Wharol e il suo compagno David Withney e altri all’interno della Glass House a New Canaan. Grazie a Johnson, Stern ottenne i primi incarichi di curatore, mentre grazie al matrimonio con Lynn Gimbel Solinger (figlia di un proprietario di grandi mgazzini nonché presidente del Withney Museum) molti incarichi professionali. Dal 1969 lo studio RAMSA (Robert A.M. Stern Architects) è arrivato ad avere circa trecento dipendenti, realizzando un numero incalcolabile di ville di campagna, musei, hotel, yacht club, oggetti di design e grattacieli per l’alta borghesia statunitense, tutti in uno stile not too modern o meglio postmoderno scimmiottando Venturi&Scott Brown, spaziando dallo shingle style ottocentesco all’Italia che aveva visitato più volte: il George W. Bush Presidential Center a Dallas del 2013 è un plagio romano di Piacentini o quantomeno di Aschieri, mentre la torre a Madison Avenue, una delle tante per cui è stato definito da Vanity Fair “The King of Central Park West”, è un pastiche di déco e neoclassicismo milanese Ponti-Muzio-Portaluppi specie negli interni.
Infine Franz Prati, nato a Domodossola nel 1944, si era laureato all’Iuav nel 1969 collaborando poi con Dardi e occasionalmente anche con Morabito, dopo il suo trasferimento a Roma dove pure ha insegnato oltre che a Bari e Genova. La sua stella polare è stata Piranesi, veneziano-romano, ma soprattutto il suo modo di disegnare “col sporcar se trova”, motto scritto a latere di una sua tavola. Un segno molto carnale, affine alla scuola romana, che ha trovato un’applicazione naturale in molte scenografie teatrali realizzate per Luca Ronconi e Pierluigi Pizzi. Di lui nel 2002 Paolo Portoghesi ha scritto “Franz Prati mette in scena nei suoi disegni affascinanti una sorta di dramma dell’architettura italiana del ‘900 creando una città onirica di impressionante densità in cui vengono a collidere, si intrecciano, si sovrappongono immagini che in modo originale si riallacciano alle opere di maestri celebri o dimenticati. Nel progetto questa bufera di immagini si placa in meditate immagini prospettiche, suggerendo spazi collettivi di grande respiro, piazze italiane non proiettate nell’orizzonte metafisico dechirichiano, ma su un orizzonte materico in cui luce, ombra, colore, segno si mescolano in un impasto saturo e caldo vicino alla fusione”. Tutti e tre lasciano un figlio maschio che più o meno continua a seguire le orme del padre, rispettivamente Francesco, Nicholas e Carlo. I funerali si svolgeranno domattina contemporaneamente, Prati a Santa Maria in Montesanto e Morabito a San Gioacchino.
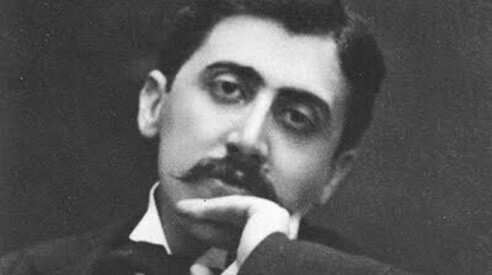

Amleto e miss Marple
Indomabile. È un romanzo sulla vita della ragazza che inventò il mistero
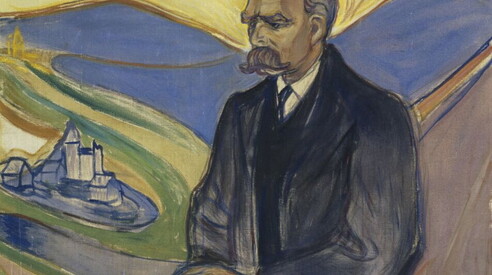
scrollarsi di dosso il passato per guardare al futuro


