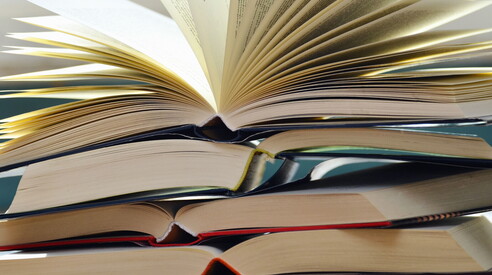
Google creative commons
saggismo
Dov'è finita la critica
Dopo Longhi, Garboli e Vallora non resta che l’appiattimento lessicale e speculativo. Oggi le forme saggistiche sono in pessima salute perchè scrittori e narratori le utilizzano come un divertissement erudito
Troppo spesso si vanno a cercare in genere letterari più tradizionalmente accreditati quelle qualità di rivelazione, di invenzione, di eccellenza stilistica e di denuncia che invece si trovano in misura maggiore nella saggistica”. Vent’anni fa Alfonso Berardinelli, con un fare profetico su un mondo culturale già al collasso, aveva intercettato l’affiorare di una letteratura incapace di generare nel lettore trasporto e stupore, quella sensazione, per dirlo con Nabokov, di “appagamento puro e assoluto che dà l’opera ispirata e ben costruita”. Oggi le forme saggistiche sono in salute ancora peggiore, sia perché l’esercizio è spesso appannaggio di scrittori e narratori che non ne fanno il principale campo di espressione ma piuttosto un divertissement (più o meno) erudito, sia perché questa scrittura vive dell’appiattimento lessicale e speculativo da prodotto mid-cult che caratterizza gran parte delle lettere italiane. Certo esistono delle nicchie in cui resiste una certa forma di saggismo, ma è impensabile immaginare oggi una forma critica che assomigli, per esempio, all’assoluta luminosità della parola di Cesare Garboli, capace di soffermarsi con la stessa straordinaria nitidezza sul caso Moro, su Moliére, sulla loggia P2 o su Elsa Morante. La scrittura di Garboli, pur toccando temi così diversi, appare omogenea grazie alla musica e al ritmo della parola, oltre che per la sua capacità di sopravvivere all’oggetto descritto, una critica cioè che si fa creazione originale e non mero momento descrittivo o di giudizio.
Risuonano della stessa sorprendente musica anche le pagine di un altro maestro della critica contemporanea, Marco Vallora (1953-2022) critico d’arte e giornalista capace, tra gli ultimi, di dare all’espressione saggistica il valore della grande letteratura. Per toccare con mano l’estrosa stratificazione della parola, l’immaginifico arsenale lessicale e la decisa acutezza dello sguardo di Vallora arriva la raccolta Scritti. Come se la parola dipingesse (Electa), una prodigiosa galleria di testi critici che dalla storia dell’arte toccano i più diversi campi del sapere mantenendo sempre la propria peculiare cifra stilistica che si posiziona tra le più importanti della cultura italiana contemporanea, vicina alle evoluzioni di scrittori come Giorgio Manganelli, Roberto Longhi e Tommaso Landolfi. Che si posi sulla cattedrale incompiuta di Pasolini Petrolio (“Non è la letteratura che latita in esso, perché è la stessa letteratura, il postulato stesso del narrare, che vien messo in discussione”), sull’amico Roland Barthes (una commovente e tesa interrogazione sulla morte), sulla possibilità dell'arte di rappresentare la menzogna (dove si pone questioni fondamentali: “Si può essere straordinariamente veri, in un discorso falso e invece terribilmente banali e menzogneri in una vera verità”), su Lorenzo Lotto (acrobazia longhiana su base arbasiniana e messa in scena in diretta del processo critico) o sull'ipocondriaco “immaginifico” Pontormo (“pittura, disfatta, di sego, e spesso spiriticamente cellulitica”) la voce di Vallora è sempre lanciata nel difficile e luminoso processo di ekphrasis, nell’esposizione verbale di un’opera d’arte, visiva o meno, attraverso una sorprendente declinazione di punti di vista in grado di far emergere nodi inediti e decisivi, generando proprio quell’appagamento di cui parlava Nabokov. Se quindi, come avvertiva già Longhi in anticipo pure sul ristagno contemporaneo, è giunto il tempo di “riconsegnare la critica non dico nel grembo della poesia, ma, certamente, nel cuore di un’attività letteraria”, non c’è via migliore che ripartire dalle pagine di Vallora.





