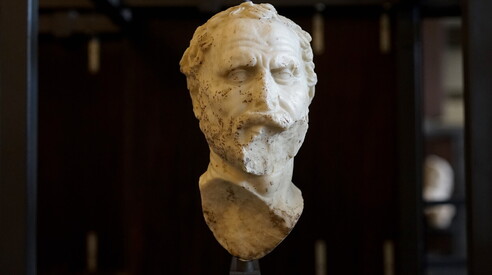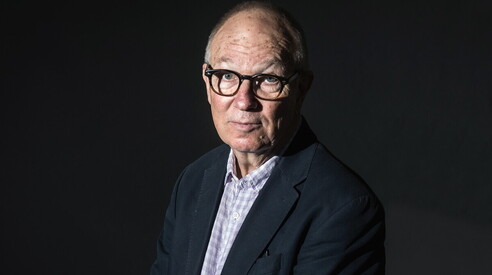Foto Ap, via LaPresse
un omaggio ai caduti
Le tante anime della Resistenza francese, a Mont Valerien. Ci scrive il ministro Nordio
Cattolici, atei, comunisti, liberali, repubblicani. Come in Italia, l’antinazismo non fu un fenomeno esclusivamente rosso
Durante una recente intervista televisiva Nicola Porro ha mostrato una fotografia che mi ritrae mentre saluto la bandiera del Mont-Valérien, il sacrario di Parigi che corrisponde alle nostre Fosse Ardeatine, perché la Gestapo vi fucilava i partigiani durante l’occupazione. La ragione della visita era molto semplice: come ministro di un governo accusato delle più funeste nostalgie dittatoriali, mi sembrava opportuno che il primo gesto della mia prima visita all’estero fosse quello dell’omaggio alla Resistenza antinazista europea. E poiché questa Resistenza era nata in Francia, quello era il luogo ideale. Peraltro sono rimasto sorpreso che nel libro d’onore dei visitatori la mia firma, tra le tante di politici illustri degli ultimi decenni, fosse l’unica di un ministro italiano. Ho anche il sospetto che di tutti i parlamentari dell’opposizione che durante il dibattito sulla separazione delle carriere hanno impropriamente invocato la Resistenza, pochi conoscano l’esistenza del Mont-Valérien. Accetto quindi con animo lieto l’invito del direttore di scrivere due righe. Ancora una volta, come ho fatto con Churchill e con il processo a Gesù, chiedo scusa per l’interferenza di un amatore in una materia che non è la sua.
La Resistenza culturale e politica al nazifascismo nacque ovviamente ben prima del conflitto mondiale, e quella italiana vi ebbe dei martiri come Matteotti, i fratelli Rosselli e altri, e molti spediti al confino, tra cui due socialisti che sarebbero poi diventati presidenti della Repubblica. Ma la Resistenza organizzata in modo militare sorse dopo l’invasione della Francia nel giugno del 1940, e la sua struttura compartimentata costituì il modello di quelle successive, dall’Olanda alla Yugoslavia, dalla Norvegia alla Cecoslovacchia e finalmente in Italia, dopo l’armistizio dell’8 settembre. Quella russa fa storia a sé.
La Francia era stata sconfitta con un Blitzkrieg da manuale in meno di trenta giorni. L’esercito si era diviso tra una difesa della Linea Maginot, irragionevole perché superflua, e una del confine belga, rischiosa perché troppo avanzata. Tra i due settori stava la foresta delle Ardenne ritenuta un ostacolo naturale. Dietro, nessuna “masse de manoeuvre”. Tanti errori strategici furono sfruttati dalle divisioni corazzate di Von Rundstedt e Guderian, che seguendo il piano del brillante Von Manstein sfondarono il fronte, arrivarono alla Manica, e costrinsero il Bef britannico alla “vittoriosa ritirata” di Dunkerque. La Francia del maresciallo Pétain chiese l’armistizio, Churchill decise di continuare la lotta “se necessario per anni, se necessario da soli” e il generale De Gaulle lanciò da Radio Londra il famoso appello del 18 giugno, invitando i francesi alla Resistenza. I suoi connazionali sul momento neanche lo sentirono, e quelli che lo fecero rimasero scettici: era un modesto generale di brigata, che sfigurava davanti al prestigio dell’eroe di Verdun. Per di più i francesi volevano una sola cosa, la pace, anche a costo di umilianti condizioni. I tedeschi la divisero in due e quella nord rimase sotto la loro giurisdizione militare.
Nel novembre del ’42, dopo l’invasione degli Alleati in Africa, avrebbero occupato anche il resto del paese. L’Italia, come è noto, entrò in guerra a cose fatte, e si prese una piccola parte della Francia meridionale. Va detto, per amor di verità, che fino al settembre del ’43 questa “enclave” italiana costituì un rifugio per gli ebrei, che il regime di Vichy faceva deportare in Germania. Lo stesso, durante il medesimo periodo, accadde in Grecia.
Se l’appello di De Gaulle fu inizialmente ignorato, non per questo tutti i francesi chinarono il capo. Un embrione di patrioti si organizzò attorno a Henri Frenay, un valoroso ufficiale che sarebbe diventato uno dei padri dell’Unione europea. Fu questo il primo esempio di gruppo paramilitare dal quale derivarono tutti gli altri. Nominato “Combat”, era costituito essenzialmente da conservatori e liberali, delusi dai partiti della Terza Repubblica e diffidenti nei confronti dello stesso esule illustre. Erano anche orgogliosamente anticomunisti. Dell’atteggiamento del Pcf dirò qualcosa tra poco. I simpatizzanti di sinistra si costituirono mesi dopo attorno a “Franc-Tireurs” di JeanPierre Lévy. Operavano soprattutto nella zona sud, ufficialmente sovrana ma pur sempre controllata dal comando nazista. Peraltro il governo di Pétain era anche più realista del re. La grande “Rafle du Vel d’Hiv”, cioè la retata del luglio del ’42 quando migliaia di ebrei parigini furono arrestati e spediti ad Auschwitz, fu opera esclusiva della polizia parigina. Se è vero che l’Italia pugnalò alle spalle la Francia alla scoppio della guerra, è anche vero che i fascisti francesi furono ancora più crudeli di quelli italiani. La banda Bonny e Lafont superò in nefandezze persino quella di Pietro Koch. Il gruppo di Henry Frenay per più di un anno operò praticamente da solo. Si trattò di un’attività essenzialmente di reclutamento e di propaganda politica clandestina. Era quasi sprovvisto di armi e refrattario ad attentati episodici, che avrebbero provocato soltanto rappresaglie crudeli. Tuttavia si organizzò militarmente, in attesa di tempi migliori: in breve arrivò a decine di migliaia di aderenti. E i comunisti? Stavano zitti, e immobili, secondo gli ordini di Mosca.
Stalin si era accordato con Hitler con il patto Ribbentrop-Molotov del 23 agosto 1939 per spartirsi la Polonia. Allo scoppio della guerra, i due erano virtualmente alleati e Molotov si congratulò con il Führer per la conquista della Francia. Il segretario del Partito comunista, Maurice Thorez, ubbidì al diktat di Mosca, disertò, scappò nell’Urss e fu condannato a morte in contumacia. I comunisti dichiararono che la guerra aveva un carattere imperialista e che quindi era colpa delle democrazie occidentali. Una pagina vergognosa, che determinò tra i compagni uno sconcerto contenuto. Alcuni mugugnarono, pochi si suicidarono, tutti ubbidirono.
La Resistenza intanto cresceva, e Frenay acquistava sempre maggior prestigio e autorità. Ma le cose cambiarono quando, nel giugno del ’41, Hitler invase l’Unione sovietica. Stalin, passato il primo momento di sconforto, riorganizzò l’apparato militare in patria e quello politico all’estero, e ordinò ai militanti europei di attaccare i nazisti con ogni mezzo. Il Partito comunista francese iniziò quella serie di attentati che avrebbe provocato tante vittime innocenti. I tedeschi, con un’ottusità pari alla loro efficienza, caddero nel tranello, e attuarono le criminali rappresaglie che, fomentando l’odio, avrebbero accresciuto le file dei partigiani. Il primo episodio avvenne il 21 agosto 1941, due mesi dopo l’attacco all’Urss, quando Pierre Georges, il “colonnello Fabien”, uccise a sangue freddo, nel metro della capitale, non uno sgherro delle SS, ma un burocratico ufficiale della Marina germanica. Furono catturate decine di ostaggi e iniziò la lugubre successione di esecuzioni svoltesi, per la più parte, al Mont-Valérien.
Henry Frenay disapprovava questa strategia ma, come Churchill davanti a Roosevelt, dopo aver resistito per primo dovette cedere per ultimo. La forza del militare comunista era meno numerosa ma più aggressiva di quella dei moderati liberali. Per di più, De Gaulle diffidava di entrambe e mirava a dirigere l’intera Resistenza da Londra, attraverso i suoi rappresentanti. Il più illustre fu Jean Moulin, paracadutato in Provenza con il compito di unificare i vari movimenti. Impresa che gli riuscì nel maggio del ’43 e che probabilmente gli costò la vita un mese dopo quando qualcuno lo tradì e lo fece catturare durante una riunione clandestina. Klaus Barbie, il boia di Lione, lo fece torturare a morte. Le sue (presunte) ceneri riposano ora al Panthéon dove furono portate una gelida mattina del dicembre 1964 alla presenza di De Gaulle, accompagnate da una retorica “oraison funèbre” di André Malraux. La sua tomba, come la casa a Caluire-et-Cuire dove fu catturato, è oggetto di ossequio: ma il simbolo della Resistenza francese, e quindi di quella europea, resta il Mont-Valérien. Qui non furono uccisi soltanto ostaggi estranei alla lotta: la più parte delle vittime fu di veri e propri patrioti combattenti, cattolici e atei, comunisti e liberali, radicali repubblicani e aristocratici conservatori. Come da noi, la Resistenza non fu affatto un fenomeno esclusivamente rosso, anche se i comunisti francesi, ancor più degli italiani, gonfiarono i numeri dei loro militanti e si arrogarono ingiustamente la leadership dell’opposizione. De Gaulle, che tra mille difetti aveva la vista politica lunga quanto la statura, li aveva comunque già neutralizzati predicando un patriottismo unitario e determinandone alla fine l’estromissione. Fu un bene per la democrazia, anche se va riconosciuto che questi stalinisti sapevano, con la stessa determinazione, uccidere e morire. La rivoluzione comunque non fu nemmeno iniziata, anche perché proprio Stalin aveva dato parere contrario. Fra tutte le polemiche che contrassegnano ogni guerra civile, e quella francese lo fu così tanto da concludersi con “une epuration sauvage”, il MontValérien resta comunque il simbolo del coraggio e del patriottismo. Per uno strano destino, a poche centinaia di metri, vi è anche la villa dove abitò Noor Inayat Kahn, una delle eroine dello Special Operation Executive (Soe) spedite in Francia da Londra per aiutare i partigiani nella lotta contro l’invasore. Noor fu uccisa a Dachau , dopo mesi di privazioni e torture: è la più nota tra le molte ragazze del Soe che si sacrificarono per la libertà. Anche per questo, l’omaggio al Mont-Valérien prima ancora che un gesto politico è un atto di venerazione e di gratitudine.