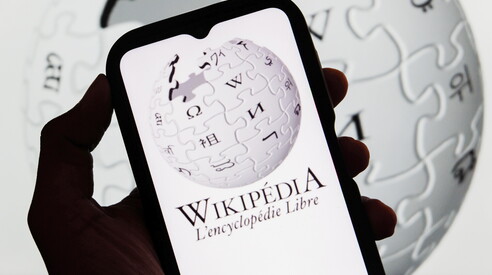facce dispari
Marcello Ravveduto: “TikTok è l'amplificatore di mafie e ‘mafiofili'”
Come funziona (e perché temere) l'ostentazione mafiosa sui social. Intervista al professore di Storia Contemporanea all’Università di Salerno e studioso dei processi di modernizzazione delle mafie
Nel sottosuolo delle mafie c’è il dark web con miniere di illegalità dall’arduo accesso; in superficie c’è TikTok per ostentare. “Nelle terre emerse dei social network” i boss si comportano “come se fossero nel loro quartiere”: la dimensione virtuale espande l’ambiente comunicativo, relazionale e simbolico in cui “si riproducono le pratiche, i codici e le narrazioni mafiose”. Fino a costituire una “mafiosfera” dove non si muovono soltanto i criminali ma i “mafiofili”, ossia gli utenti che commentano, condividono e diffondono i contenuti degli appartenenti ai clan pur senza appartenervi. Sono osservazioni, compresi i citati neologismi che avranno forse fortuna, tratte dal secondo Rapporto su “Le mafie nell’era digitale” edito da FrancoAngeli e curato da Marcello Ravveduto, professore di Storia Contemporanea all’Università di Salerno e studioso dei processi di modernizzazione delle mafie.
Perché il Rapporto dedica un focus a TikTok?
È il social network che più di ogni altro ha modificato il sistema informazionale delle mafie. Prima occorreva la mediazione di registi, scrittori, giornalisti. TikTok invece, con la videocamera retroversa dello smartphone, ha consentito l’autorappresentazione dei mafiosi, che vi si sono adattati in una narrazione autoreferenziale e mitopoietica. Parlano di sé per accrescere il proprio mito e propagandano il proprio mondo replicando, con meccanismi irriflessi, il linguaggio del marketing. Lo scopo non è nuovo, ma il mezzo lo espande: cercare la legittimazione sociale. I social amplificano il saluto al bar o l’inchino della statua del santo in processione per manifestare il controllo del territorio non solo fisico ma virtuale.
Quali sono le mafie più attive su TikTok?
Le organizzazioni che hanno maggiore tradizione di presenza pubblica in strada. Prima fra tutte la camorra soprattutto cittadina e dell’hinterland napoletano, poi le batterie foggiane e i clan di spacciatori dei quartieri periferici di Roma Sud. In Sicilia sono più effervescenti i catanesi, mentre la ’ndrangheta è poco visibile tra le ’ndrine del Tirreno e per nulla tra quelle dello Ionio. Però ci sono rampolli di ’ndranghetisti residenti al Nord che sfoggiano lussi da giovani ricchi. Spesso le performance sono condite di cultura hip hop, trap, di varie suggestioni metropolitane e mode estetiche che vengono condivise: dal taglio dei capelli a certi tatuaggi e riferimenti a personaggi dell’immaginario come il Joker.
La “mafiosfera” è territorio dei giovani?
È stata la generazione tra i millennial e la “zeta” a scoprire TikTok, ma ben presto lo hanno apprezzato anche gli utenti più maturi. Ora le donne dei camorristi hanno un ruolo molto attivo e quelle dei carcerati hanno costituito un vero e proprio genere narrativo.
Quali sono i temi ricorrenti?
S’ispirano a qualche celebrity e a modelli acquisiti dalla televisione. Se si riguarda il film “Reality” di Matteo Garrone bisogna ammettere che fu lungimirante perché il mondo dei tiktoker ne discende. L’elemento ricorrente è lo sfoggio del benessere, centrale nella propaganda della “mafiosfera”. Non si racconta come viene conseguita la ricchezza, ma i suoi aspetti positivi senza violenza. Le mogli dei mafiosi mostrano come vestono, trucchi e profumi, gli arredi e il cibo che è sempre una cartina di tornasole per individuare il confine tra élite e popolo. I mafiosi ostentano la sovrabbondanza, perché chi è più ricco più mangia. È la rivalsa su un passato di deprivazione.
Non ci sono aspirazioni borghesi?
Negli ambienti camorristici nessuna. Esibiscono una sorta di identità popolare fondamentalista in opposizione a quella borghese, si sentono titolari di radici che devono essere difese e raccontate anche se si sono piegati alla società dello spettacolo. È una cultura, non solo una scelta né una subcultura, che ha trovato in TikTok il veicolo per essere comunicata. Prima c’erano solo i neomelodici. Oggi sono rimasti come colonna sonora in continuità storica.
Gli intellettuali intercettano questo mondo?
La cultura borghese non vi si mischia e quando lo descrive lo media con la propria trasfigurazione immaginaria. Spiace dirlo, ma la retorica delle “due Napoli” riflette una verità. Ci sono due culture antitetiche con qualche alleanza di necessità, perché il ragazzo di buona famiglia che compra la cocaina deve sapere dove trovarla.
TikTok ha anche un impiego criminale operativo?
Otto volte su dieci è un canale di propaganda normalizzatrice. Nei casi rimanenti è usato per minacciare, raccontare faide, fare ‘dissing’ sui clan rivali. Intanto sappiamo che si indaga sul fenomeno delle ‘live’ per capire se le donazioni del pubblico celino anche forme di monetizzazione illecita o di riciclaggio.
Chi sono i “mafiofili”?
Disse Giovanni Falcone: “Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”. La comunità “mafiofila” contempla quanti vengono suggestionati dalle narrazioni mediali e promuovono contenuti apologetici o moralmente ambigui per un legame emotivo con l’organizzazione. Non sono affiliati, ma attingono dalla realtà o dalla fiction simboli, icone e linguaggi mafiosi.
Durerà il successo di TikTok o le mafie troveranno altri canali di rappresentazione?
Quali che siano i cambiamenti, TikTok è una istantanea necessaria del presente che ci mostra pure un’altra cosa: l’immaginario mafioso si è globalizzato. Ormai dall’Italia al Messico certi contenuti s’assomigliano.