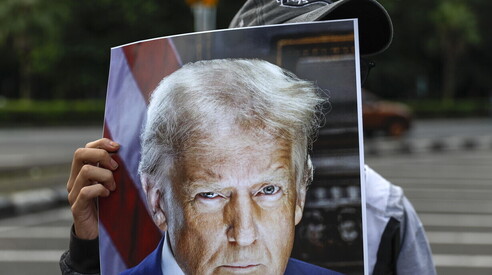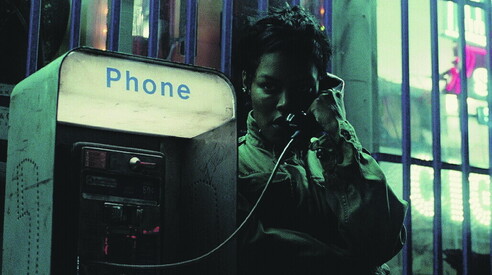Paul Cézanne, Il bacio della musa, circa 1863
Addio alle muse, relitti di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto
Nella nostra epoca che teme la dipendenza e confonde l’ammirazione con la subordinazione, la parola “musa” suona come un insulto. Ma forse era solo un altro modo di dire amore. Da Beatrice a Diane Keaton
È morta Diane Keaton, e i giornali, quasi all’unisono, l’hanno ricordata come la musa di Woody Allen. Subito, da più parti, è arrivata la reazione sdegnata: ecco, ancora una volta, una donna definita solo in funzione di un uomo. Si è detto: perché le muse sono sempre donne e mai uomini? Non è forse questa la prova di un retaggio patriarcale, di un ego maschile che non sa pensare l’alterità se non come subordinazione? Non ci sono (concedetemi) “musi” che ispirano le donne?
Eppure, guardando le cose da un’altra prospettiva, il concetto di musa non appartiene alla logica del dominio, ma a quella della complementarietà. La musa non è un’appendice, ma un principio ispiratore, un angelo della soglia. L’artista non la possiede: la riconosce, la segue, talvolta la teme. In lei vede incarnarsi qualcosa che lo oltrepassa e che, proprio per questo, gli consente di oltrepassare se stesso. La musa per eccellenza della nostra letteratura, Beatrice, non è un personaggio subalterno, ma una guida che, attraverso la propria presenza, apre a una vita più alta. Non lava le camice, ma indica, preannuncia. La musa è complice di chi si sta spendendo per realizzare un valore più grande.
Quando si ha successo e un’altra persona ci accompagna e ispira, invece che sfruttare utilitaristicamente la relazione con noi, si esprime ammirazione. In questo senso, la musa è l’immagine più alta della partecipazione: non solo una fusione sentimentale, ma un’intesa che rende ciascuno condizione dell’altro. L’artista è l’occhio che vede, ma la musa è ciò che gli consente di vedere. Solo dentro questo scambio, in cui lo sguardo si fa riconoscente, nasce l’opera, e forse anche l’amore.
Oggi, però, quella reciprocità è diventata sospetta. Viviamo in una cultura che teme la dipendenza e sospetta l’ammirazione. Ognuno deve bastare a sé stesso: l’altro è al massimo un alleato, mai un principio ispiratore. Così, laddove un tempo si parlava di musa e di artista, oggi si parla di partner in una accezione funzionale e utilitaria. Non si è quasi mai simpatetici della vicenda esistenziale dei partner, se non nella misura in cui sono funzionali alle nostre esigenze. In recenti film di successo come “Dieci giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, il compagno è una appendice inutile della vita familiare, il cui unico valore consiste nel provvedere economicamente a una famiglia che lo sopporta quando non lo disprezza. In questo contesto, la musa è una figura anomala, quello che, in gergo, si chiama un unicorno; un outlier. E’ una figura superiore che riconosce nell’impresa di chi la segue che cerca di superare i propri limiti. La musa è già oltre questi limiti. Invece il muso è la normalità, quello che ci si aspetta come normalità, ma non può essere ringraziato perché dovrebbe essere riconosciuto come araldo di qualcosa di superiore che guida la sua donna; inconcepibile! Le donne di successo – da Angela Merkel a Joanne Rowlings, da Lady Gaga a Rita Levi Montalcini, da Giorgia Meloni a Oprah Winfre – non desiderano avere musi al loro fianco. Nessuna donna vuole più essere musa, e nessun uomo osa più dichiararsi ispirato. L’autonomia vuole solitudine e la partecipazione è ridotta a scambio.
Al contrario, quando un uomo riconosce nella propria vita la presenza di una donna che gli ha dato coraggio, visione o respiro, non la riduce affatto: la celebra. Quando una donna riconosce di aver aiutato in qualcuno forza e direzione, non si umilia: si apre a una forma più ampia di sé. Ovviamente nulla vieta di giocare con i generi in tutte le combinazioni. E tuttavia, questa dinamica a molti dà fastidio: come se ammettere che l’altro ci ha reso migliori significasse perdere la propria indipendenza.
La musa è diventata così una figura arcaica, un relitto di un tempo in cui si poteva ancora ammirare senza sospetto. E con lei scompare l’idea che l’amore – o la creazione – nascano da un incontro che trascende entrambi. Nessuno è più disposto a essere guida, e nessuno accetta più di essere guidato.
Laddove artista e musa erano legati da una cultura della partecipazione, in cui nessuno era funzione dell’altro, ma condividevano l’avventura dell’arte libera, così oggi la mentalità utilitarista reinterpreta queste figure in chiave di rapporto di servitù. Ma la musa non era un Sancho Panza o un Leporello, e nemmeno una cameriera o un maggiordomo, bensì una figura alta che amava gli sforzi dell’artista. Alla vista di Beatrice, Dante scriveva “li occhi mi caddero già nel chiaro fonte / ma veggendomi in esso i trassi a l’erba / tanta vergogna mi gravò la fronte”. Nessuna donna, oggi, abbasserebbe lo sguardo per riconoscere la guida di un muso. Game over.