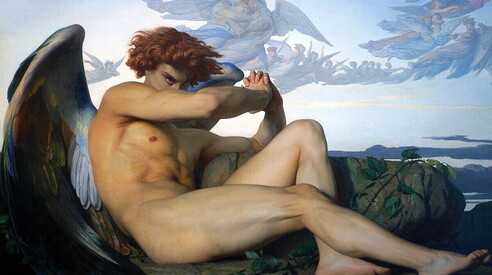
Alexandre Cabanel, “L’angelo caduto”, olio su tela, 1847
Magazine
I codici ciechi della rabbia: cosa succede a banalizzare la collera quotidiana
L’emozione si contamina e si svuota, con ingiustizie reali e manipolazioni digitali. Quando l’indignazione quotidiana si trasforma in gesto automatico, resta solo il rumore
"Se non vi arrabbiate, vuol dire che non siete attenti”. Lo slogan usato sin dal 2017 nelle proteste contro Donald Trump è la pietra angolare di molti ragionamenti sulla sconfitta dei moderati o, se preferite, sulla vittoria del populismo più estremo. A ogni latitudine. Perché se, a giudicare dagli eventi drammatici degli ultimi tempi, di “attenzione” pare essercene parecchia, una domanda striscia nel retrobottega delle nostre migliori intenzioni: si può vivere civilmente senza dover essere incivili contro chi impedisce il vivere civile? Dall’omicidio dell’attivista statunitense Charlie Kirk alle derive violente di proteste nate pacifiche – tanto per rimanere agganciati alla cronaca – la rabbia stupra le migliori intenzioni, si maschera da rimedio ideale, ci induce nella tentazione di continuare a spiegare la crisi della democrazia – perché anche di questo si tratta – usando dualismi rassicuranti come liberalismo e autoritarismo, islamismo e modernità, Meloni e Schlein, colpi di genio e colpi in canna. Ci si interroga da sempre sulle sue origini, come se fosse un’entità multiforme: in realtà l’unica certezza che la storia ci ha consegnato è che la rabbia è piatta, sempre uguale in ogni latitudine dell’intolleranza, in ogni anfratto di insoddisfazione, in ogni meandro di incultura. Facile osservarne gli effetti che ci vengono incontro o che ci prendono alle spalle, meno facile circoscriverne ambiti e sorgenti: “Tutti a dire della rabbia del fiume in piena, e nessuno della violenza degli argini che lo costringono”, ammoniva in una delle sue frasi più celebri Bertolt Brecht.
Guerre, violazioni dei diritti umani, disuguaglianze sociali. Il sociologo Carmelo Guarino analizza le fonti di rabbia oggi
Nel suo recente libro “Arrabbiati. Alle radici della rabbia sociale”, il sociologo Carmelo Guarino, professore associato di Sociologia generale presso l’Università Internazionale Uninettuno di Roma, specializzato in mutamenti sociali, prova a mettere ordine nel sentimento. E snocciola i dati della sua ricerca. “Con riferimento alla situazione mondiale, le ragioni che maggiormente sembrano ingenerare rabbia nelle persone sono rappresentate dalle guerre e dalla violazione dei diritti umani. Seguono le disuguaglianze sociali, e l’incapacità e l’inadeguatezza della politica” scrive Guarino. “Per quanto riguarda l’Europa, invece, le ragioni che sembrano ingenerare rabbia nelle persone sono rappresentate dalla riacutizzazione di sentimenti xenofobi e discriminatori nei confronti delle minoranze, e dal venir meno di una società equa e inclusiva. Se, invece, l’osservazione si sposta sull’Italia, la rabbia sembra maggiormente ingenerata da fenomeni come la violenza sulle donne. Seguono la corruzione della politica, l’inefficienza della sanità pubblica e il rischio della sua progressiva privatizzazione”.
Poiché l’algoritmo social non tollera il vuoto di informazioni, in assenza di notizie lo riempie con esche per aizzare la rabbia
Se il messaggio è chiaro – la rabbia è inequivoca nei suoi effetti come un on/off - quel che resta da decrittare sono i codici. Codici segreti come quelli dell’algoritmo che governa la nostra interazione social. Nessuno sa come funziona, tutti sanno che funziona. Sulla rivista statunitense The Atlantic, Charlie Warzel ha scritto: “Forse l’aspetto più sorprendente, nelle reazioni all’omicidio di Charlie Kirk, è il modo in cui le persone hanno cominciato a commentare senza sapere niente su chi lo aveva ucciso”. Ed ha ammesso che “è difficile non notare che c’è qualcosa di velenoso nell’architettura dei social e nel modo in cui la tecnologia richiede non solo la nostra attenzione ma anche le nostre emozioni, meglio se esasperate”. E’ questo il ruolo perverso dell’algoritmo. Il sistema non tollera il vuoto di informazioni e quando mancano fatti o notizie credibili, i buchi vengono riempiti con esche per aizzare la rabbia, foraggiare teorie del complotto, e versare un’abbondante dose di veleno nella pozione dell’allarmismo. Risultato, per Warzel, è “la priorità del coinvolgimento degli utenti, amplificando la voce di quelli più rumorosi, perché saranno loro ad attirarne di nuovi. Quest’attenzione vale molti soldi, sia per chi la sa sfruttare sia per le aziende tecnologiche”. Pensare alla rabbia esclusivamente come frutto di una recrudescenza di ignoranza o di una modernissima schiavitù da internet è però un errore, fondamentalmente storico. Il governo dell’aggressività, da Thomas Hobbes in poi (e siamo nell’Inghilterra del 1600, mica nel 2025 nella California di Mark Zuckerberg), è stato inquadrato come un requisito fondamentale di una società funzionante. Lo psicoanalista Josh Cohen, professore di teoria letteraria moderna alla University of London, ne ha scritto sull’Economist: “Non tutti i pensatori vedevano con favore la repressione della violenza. Friedrich Nietzsche, che nel 1887 pubblicò ‘Genealogia della morale’ proprio mentre Freud faceva le sue prime escursioni nella psicoterapia, considerava la morale come la forma suprema di aggressività passiva, un espediente utilizzato dalle masse deboli e rancorose per frenare la volontà dei loro superiori, più forti e creativi”.
Ci dicono che siamo istintivamente portati a essere aggressivi. La domanda è: perché?
“Niente ci fa più paura che sentirci indifesi”, ragiona lo psicoanalista Josh Cohen. L’aggressività come balsamo contro l’impotenza
“La risposta psicoanalitica è che niente ci fa più paura che sentirci indifesi, e questa paura ci assale molto più spesso di quello che pensiamo” ragiona Cohen. “L’aggressività è un balsamo contro la sensazione d’impotenza, un modo per assicurarci che siamo i dominatori, non le vittime indifese del mondo che ci circonda”. Ci sarebbero molti buoni motivi per restare calmi. Innanzitutto scientifici. Uno studio condotto dall’Irving medical center della Columbia University di New York, i cui risultati sono stati pubblicati dal maggiore settimanale tedesco Der Spiegel, dimostra che “un attacco di rabbia di otto minuti può compromettere la funzione dell’endotelio vascolare, il rivestimento interno dei vasi sanguigni che ne regola il restringimento e l’allargamento, aumentando la possibilità di danni a lungo termine e lo sviluppo di aterosclerosi, infarti e ictus”. Eppure è come se il nostro cervello talvolta gridasse “abbasso la normalizzazione”, dandoci l’illusione che l’unico modo per resistere al male che si fa regola, sia rimanere costantemente infuriati. Come il protagonista di “Quinto potere” Howard Beale, in cui Peter Finch anticipa drammaticamente la figura del predicatore mediatico con un personaggio shakespeariano, colto nella sua follia rivelatrice, che soccomberà inevitabilmente sotto il peso del suo stesso dono. Beale/Finch affida la sua frustrazione e la sua paura alla celebre frase: “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!”.
L’illusione è costante: se fremiamo dalla rabbia – così almeno ci dice la logica – non rischiamo di diventare acquiescenti. “Il guaio”, ha raccontato su Medium la scrittrice Mirah Curzer, “è che anche le emozioni si normalizzano (a causa del cosiddetto ‘adattamento edonico’, per cui le cose nuove ed entusiasmanti a lungo andare ci sembrano banali, e certe situazioni terrificanti prima o poi non ci fanno più soffrire). Perciò non è egoistico, anzi forse è proprio nostro dovere, ogni tanto prendere le distanze dall’orrore e continuare la nostra vita, specialmente nei suoi aspetti più piacevoli. Chiamiamolo ‘prenderci cura di noi stessi’, se vi piace questa brutta espressione, ma è anche un modo per evitare che le nostre emozioni si appiattiscano. E’ strano pensare che angoscia, paura e indignazione possano creare assuefazione: di solito riserviamo questo concetto a esperienze che, almeno all’inizio, sono piacevoli. Ma, come hanno sempre sostenuto i buddisti, l’avversione e il desiderio sono due facce della stessa medaglia: sia che moriamo dalla voglia di qualcosa o che la detestiamo per qualche motivo, si tratta sempre di un’ossessione”. La trappola, ben nota a chi frequenta i social network, è quella dell’eccessiva semplificazione o meglio della fuga dinanzi alla complessità delle cose. Il fanatismo in tal senso costituisce un perfetto terreno di coltura del germe della rabbia. Scrive Carmelo Guarino, riprendendo un ragionamento del politologo Angelo Panebianco: “Fanatico è colui che di fronte alla complessità del mondo, nonché all’ambiguità morale che tale complessità porta con sé, se ne ritrae e, per sfuggire all’angoscia, sceglie di aderire a una visione ipersemplificata di quel mondo, ove tutto è chiaro, cristallino, ove soprattutto il bene e il male sono facilmente identificabili e, per conseguenza, impegnarsi per schiacciare le forze del male è un imperativo morale. Il fanatico vede solo due colori: bianco e nero. E non è in grado di accettare l’idea che la realtà sia costituita da infinite gradazioni e sfumature”. La sensazione, che sperimentiamo ogni giorno leggendo i giornali, è che la cattiveria sia un collaudato collante politico, un segreto (mai troppo segreto) di successo. E non da oggi.
Secondo la politologa e storica Nadia Urbinati, la “rabbia è la passione che domina la politica del XXI secolo” che contestualmente genera e riflette sia la propensione alla semplificazione della realtà, rifiutando a priori l’idea della complessità, che la tendenza alla divisione tra amici e nemici, tra buoni e cattivi, tra noi e loro. Ci hanno insegnato che la rabbia è una delle sette emozioni fondamentali insieme a gioia, disgusto, disprezzo, tristezza, sorpresa e paura. Secondo gli psicologi servono a recapitarci dei messaggi. Come dei fedeli messaggeri, le nostre emozioni hanno uno spiccato senso del dovere: non accetterebbero mai l’idea di rinunciare alla missione. Quindi ogni volta che cerchiamo di intralciare la strada dei messaggeri, loro faranno in modo da trovarne una nuova: facendosi largo con ogni mezzo, scavando strade nuove, scavalcando muri e magari facendo qualche danno. Tutti abbiamo contezza di cosa significhi vivere una rabbia sempre più bruciante, oppure lasciare che una tristezza si tramuti, incontrollata, in un dolore sempre meno sopportabile. Ad esempio, molti di noi hanno decrittato che la tristezza può scaturire dall’incontro tra il desiderio e i suoi limiti. Victor Hugo scriveva della malinconia che è “la gioia di sentirsi tristi”. Può non piacere, ma facendo i conti coi nostri casini quotidiani risulta abbastanza vero. Charles Baudelaire parlava di spleen: quel piccolo miracolo che si realizza quando la malinconia si traduce in una fertile produzione artistica e la sofferenza si trasforma in creatività. L’arte come un germoglio di una terra coltivata a infelicità, insomma.
Allenamento mentale e conoscenza sembrano essere armi importanti contro la deriva del tutti contro tutti. Lo scrittore Oliver Burkeman qualche tempo fa ha dato una sua ricetta, sul Guardian: “Se vogliamo lanciare una campagna contro qualcuno o qualcosa, saremo molto più efficaci se riusciamo a mantenere un certo distacco, invece di lasciarci trascinare in un futile turbine di rabbia, che va unicamente a vantaggio dei nostri avversari. Insomma è come rafforzare un muscolo. Potremmo chiamarlo addestramento alla resistenza”. Sembra facile, ma non lo è. Perché di pietre della rabbia è pieno il nostro cammino. La ricerca di Guarino fotografa lo stato delle cose in Italia, oggi. In ambito personale e assoluto ci si arrabbia soprattutto per l’aggressività e la scortesia delle persone, e a seguire per l’aumento del costo della vita, per l’incertezza relativa al futuro dei propri figli, per l’insicurezza e la malamministrazione delle città in cui si vive. Invece, in relazione alla vita quotidiana l’azione più urente è esercitata dal traffico nelle città. Solo dopo ci sono le offese o le provocazioni subite, e i pensieri destinati a persone o eventi passati che hanno ingenerato un turbamento o una ferita. Oggi la rabbia è un fuoco facile da appiccare, difficile da governare. Perché alla miccia conosciuta si affiancano mille focolai accesi chissà quando e chissà da chi. Lo sanno bene i padroni istituzionali delle menzogne, che alimentano ribellioni da tinello strutturate in modo da far venir giù un palazzo. L’estremizzarsi delle disuguaglianze e il diffondersi strisciante di una povertà globale che riguarda tasche, stomaci e menti, ci forniscono importanti indizi sulla scena del delitto. Ma paradossalmente acuiscono il mistero di rabbie ordinarie, banali e per questo ancora più allarmanti.
La scorsa settimana a Catania c’era una cena di compleanno in un noto bistrot della movida cittadina. Candeline colorate, gente festante, fiaccole scenografiche. Poi è arrivata la torta sulla quale il festeggiato, incitato dagli ospiti che cantavano “tanti auguri a te”, ha cominciato a sferrare colpi di coltello: sul dolce era ritratto il volto del sindaco della città, Enrico Trantino. Tutto è stato ripreso dagli smartphone degli invitati e postato su Instagram, tra canti e insulti, tra sorrisi e selfie vista torta sfregiata. Erano tutti ben visibili, tranquilli e leggeri. Come se niente fosse. Qual è il peso sociale di una rabbia senza entusiasmo?
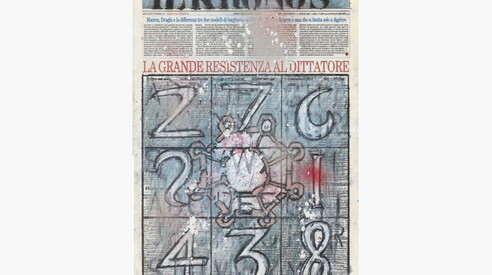
disegni e giornali




