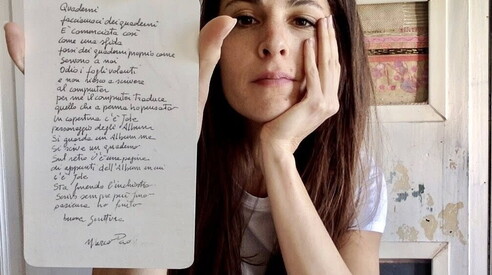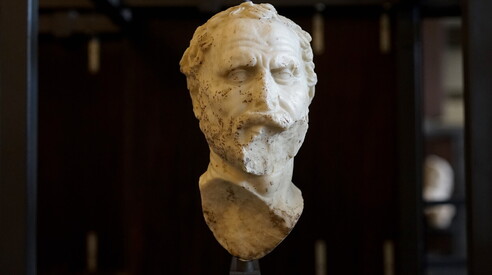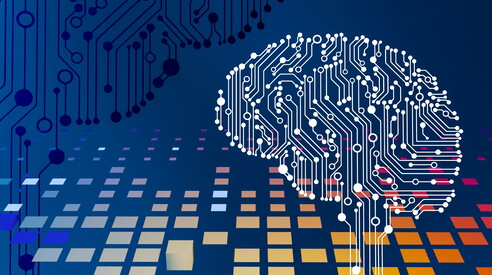
foto Unsplash
Ritorno al passato
Come rendere la Filosofia a prova di AI? Basta abolire la tesi di laurea
Più che in altre materie, qui le tesi rischiano di trasformarsi in nebulosi centoni prodotti dalle macchine. Un esercizio inutile per gli studenti mediocri e superfluo per quelli bravi. Lo spiega bene Massimo Mugnai in "Come non insegnare filosofia"
Filosofemi come “La storia è il moto del nulla verso il tempo”, “L’universo nasce da molta passione” o “Il gatto è indispensabile al progresso della religione” provengono da una vera e propria rarità, i “Pensées et mots choisis du philosophe mécanique universel”, pubblicati nel 1774 a Nantes da Absalom Amet; rarità esacerbata dalla circostanza che detto libro non esiste, ma viene soltanto citato in un sublime raccontino de “La sinagoga degli iconoclasti” (Adelphi) di Juan Rodolfo Wilcock. È una lettura istruttiva per i docenti universitari di Filosofia, che ai nostri giorni si interrogano sulla provenienza delle tesi dei loro laureandi, chiedendosi se certe stramberie derivino da uno spirito troppo ardimentoso o dagli automatismi imbizzarriti di ChatGPT.
Appare infatti evidente che, più di altre materie, le tesi in Filosofia sono a rischio di venire trasformate in nebulosi centoni prodotti dall’AI. Non mi riferisco a quelle di argomento storico-filosofico, che sono tuttora radicate (spero) nello scandaglio di fonti, bensì a quelle di argomento filosofico-teorico, in cui la produzione originale di pensiero è per definizione fondata non sulla verificabilità di dati pregressi ma sul sapiente utilizzo di termini, concetti e relative sfumature. È forte la tentazione di affidarsi all’aiutino tecnologico con prompt tipo “analizza il rapporto fra metafisica formale e complementarità fenomenologica”. Così come il colpo di genio, la supercazzola sarebbe sempre dietro l’angolo.
Per quanto le università possano dotarsi di software in grado di calcolare la probabilità che un testo sia stato generato artificialmente, non ne avranno mai la certezza assoluta. Men che meno ci riuscirebbero analizzando tesi che, già quando erano scritte in corsivo, si facevano un vanto del vago impressionismo cui ChatGPT ricorre a iosa (Heidegger, temo, ne utilizzava una versione sperimentale). Che fare? La mia modesta proposta è di contrastare l’andazzo con una riforma delle prove atte a conseguire la laurea in Filosofia: va abolita la tesi, inutile per gli alunni mediocri e superflua per quelli bravi, che iniziano subito a pubblicare i primi articoli scientifici.
La laurea triennale può essere rilasciata dopo un colloquio, di fronte a una commissione plenaria, relativo alla lettura integrale di quattro classici della Filosofia, scelti all’interno di un canone stabilito dall’università. L’innovazione sarebbe un ritorno alle origini, poiché le quattro letture integrali erano esattamente ciò che prevedeva nel 1923 la riforma Gentile per il triennio dei licei, il cui livello dell’epoca è paragonabile forse (forse) all’attuale università.
Lo spiega bene Massimo Mugnai in “Come non insegnare la Filosofia” (Raffaello Cortina): i manuali, con le loro deliranti infarinature su decine e decine di filosofi all’anno, erano giunti solo tredici anni dopo, una volta appurato che gli studenti non fossero in grado di leggere. Quanto alla magistrale, la laurea può essere conferita dopo che il candidato abbia dimostrato di saper dibattere pubblicamente in modo rigoroso attorno a un tema teorico afferente al proprio indirizzo di studi: estetico, morale, teoretico, politico, etc. Tale discussione senza tesi sarebbe un aggiornamento delle quaestiones dibattute nelle scholae medievali, quando la capacità di esporre un’argomentazione anche all’impronta era ritenuta criterio dirimente nel vagliare la riuscita degli studi.
Un’esigenza del genere si rende quanto più urgente ora che non c’è più bisogno né modo di valutare l’abilità di qualcuno nella stesura di testi, data l’assodata ibridazione con le macchine, che in Filosofia ha partorito ad esempio “Ipnocrazia” (Tlon) dello pseudo-Jianwei Xun, in realtà Andrea Colamedici con l’AI. È soltanto l’ultimo aggiornamento del filosofo automatico di cui scriveva Wilcock, quella macchina capace di combinare le parole in modo tale da ottenere con disinvoltura frasi assurde come “Tutto il reale è razionale” o “L’inferno sono gli altri”.