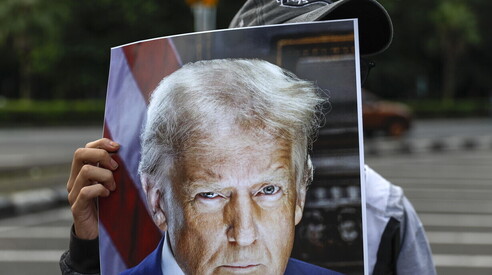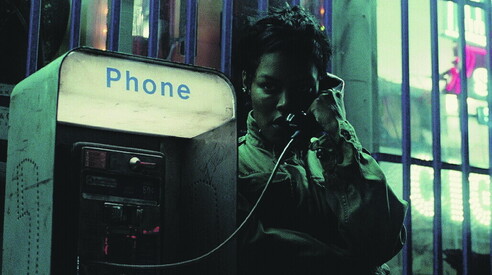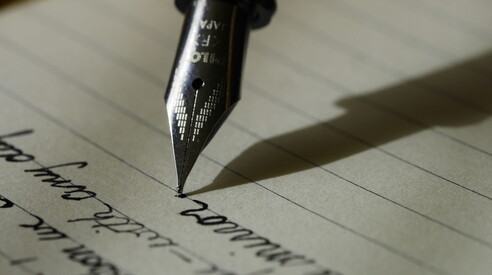
Foto di Aaron Burden su Unsplash
l'analisi della scrittura
Parole, maschere e poemi. Un'antologia ricorda la scrittrice Giusi Verbaro
A dieci anni dalla scomparsa, la raccolta La parola che quadra e che scompiglia celebra la sua bio-poesia: ossimori, cicli naturali e l’anelito costante di un nuovo inizio. Quaranta anni di versi come orme di un ritorno a sé
Giusi Verbaro è stata un’interessante scrittrice che ha vissuto e operato tra la Calabria e la Toscana. Le sue carte, che comprendono un florido epistolario con i maggiori intellettuali del secolo scorso, sono oggi conservate presso l’Archivio di stato di Firenze. A dieci anni dalla scomparsa Rubbettino propone un’ampia antologia poetica, La parola che quadra e che scompiglia. Poesie 1971-2013 (a cura di Caterina Verbaro, prefazione di Daniele Piccini, 200 pp., 22 euro). Ripercorriamo così quarant’anni di letteratura, suddivisa in tre grandi fasi con una “preistoria poetica” (1971-1978) e un repertorio di brani saggistici. Caterina Verbaro – figlia dell’autrice e docente di Letteratura italiana contemporanea alla Lumsa – ha selezionato con sollecitudine i testi abbinandoli ad alcune voci critiche. “Siamo davanti al peregrinare di una parola infinitamente scomponibile e riadattabile – osserva nell’introduzione –, segnacolo di un’inquietudine perenne che spira nei versi della poetessa e che è insieme forma e contenuto del suo itinerario letterario”. Sospesa tra la lezione di Eugenio Montale e quella di Mario Luzi, forte del suo percorso di studi in biologia, Giusi Verbaro offre al lettore immagini icastiche, traslucide, visivamente disposte in caselle dislocate, dando l’impressione di una solida scrittura modernista (prevalgono l’endecasillabo e il settenario sapientemente rimodulati secondo scansioni da classicismo “paradossale”). Forse una selva da attraversare: il doppelgänger, la maschera metafisica, la Calabria grecanica, l’intonazione civile, la psicanalisi, il mare-poema. Piccini sottolinea come il discorso di Verbaro sia di fatto legato al bios: “Si parla infatti di cicli, di diagrammi stagionali, di seminagioni e fioriture, di autunni che interrompono fulgori d’estate che si vorrebbero sempiterni”.
La “bio-poesia” di Verbaro è allora lo specchio ustorio di un autobiografismo celato tra le radure, i ranuncoli e i papaveri che aspira a farsi “fabula archetipica e quindi collettiva” (Remo Pagnanelli). Potrebbe dirci qualcosa in più una prospettiva d’analisi ecocritica? In verità, nella dizione di Verbaro sembra domini su tutti il tema ulissiaco del ritorno al sé: questa è la traiettoria segnata da Itaca Itaca (1988) e da Isola (2004), due raccolte antologiche ammannite dalla poetessa. Questo è il senso di versi radicalmente ossimorici (“Forse ho l’età degli ultimi arrivati. Sono / figlia ai miei figli”) entro cui possiamo scorgere il laborintus di un’alta, benché sofferta, fiducia – Seamus Heaney direbbe “credito” – nella poesia: “Volli spezzare il cerchio: fu la parola / il grande inganno il sonno, / lo sgomento l’antitesi il riscatto: corpo / desiderato, la poesia. Scrivendo / ho rotto l’ordine la stasi / o ho ricomposto in lucida armonia / ciò che si dissipava nei silenzi?”. Il potere generativo del logos e il poeta come viator, pellegrino (secondo Daniele Maria Pegorari si tratta di una “volontà d’incessante cammino”): nel viaggio salino di Verbaro non manca mai l’amore e l’auspicio di un nuovo inizio. In una lettera del marzo ’82 Giorgio Caproni osserva: “Dovunque, anche dove la parola è più straziata, trovo ‘leggende ed allegria’, ‘bandiere d’amore controvento’. Lei, cara Giusi, ha un’orchestra ricchissima di timbri, dove gli ottoni si alternano di continuo ai legni e agli archi”. Verbaro pare spingere costantemente il gesto verbale “oltre il limite”, sulla soglia di una trasognata trascendenza. “L’ala ci sfiora piano. Sarà nadir / o zenit il punto in cui converge / l’umano col divino?”.