
In quell’anno “arrivò anche Luis Buñuel un paesino dell’Aragona che contava ‘due chiese e sette preti’ (Olycom)
la storia
Luis Buñuel, in quell'irripetibile Parigi
Dal Medioevo spagnolo ai café di Montparnasse, dove nel 1925 si girava in ghette, gilet e bombetta. La Ville Lumière del regista e sceneggiatore messicano-spagnolo, dove si lanciava il Surrealismo “per far esplodere la società”
A venticinque anni lo manteneva la mamma. Che gli garantì laute e regolari mancette in cambio di un posto fisso all’Istituto di Cooperazione Intellettuale di Parigi. Il posto non fu nemmeno mai cercato. Nonostante questo (e nonostante il notaio di famiglia glielo sconsigliasse) gli finanziò il primo film. Venticinque mila pesetas, non proprio bruscolini. Metà della cifra fu scialacquata nei locali notturni – e addio lungometraggio. Poi il giovanotto ebbe un soprassalto. “Una certa serietà si imponeva, dovevo pur combinare qualcosa”, scriverà anni dopo, ricordando quei giorni – e pensò: un cortometraggio per salvare la faccia? Premessa: ciò che non fa di questa storia una storia di ordinario bamboccionismo è che qui niente è ordinario. Quel ragazzo che cent’anni fa, proprio in questi giorni, faceva svagato ingresso in una Parigi affollatissima di émigré era Luis Buñuel. Il cortometraggio di riparazione, “Un chien andalou” – un capolavoro scritto in una settimana nell’atelier di Figueras di Salvador Dalí, amico inseparabile.
Ogni mattina i due si incontravano, cacciavano la fidanzata di Dalí e discutevano delle immagini che avevano sognato la notte precedente, soffermandosi su quelle più astruse e rifiutando quelle che promettessero anche solo una vaga possibilità di essere decifrate a livello intellettuale. La pellicola che ne uscì durava diciassette minuti. Protagonisti, Pierre Batcheff e Simone Mareuil, che pochi anni dopo si sarebbe suicidata cospargendosi di benzina e dandosi fuoco. I ruoli minori furono affidati ad amici e parenti. Il regista si riservò quello dell’uomo col rasoio – l’occhio inciso era quello di una mucca, come fu costretto a rivelare lo stesso Buñuel dopo alcuni episodi di urla e svenimenti da parte di alcuni spettatori.
“Ho avuto la fortuna di passare la mia infanzia nel Medioevo”, ha scritto il regista nella portentosa autobiografia “Dei miei sospiri estremi”. Il testo è preceduto da una specie di avvertenza sull’inaffidabilità della memoria. Dall’uomo che ci ha servito su un piatto le scorrerie dell’inconscio lo consideriamo un colpo basso. Non fosse che l’introduzione contiene una perla, questa: “Ho immaginato spesso di inserire in un film una scena con un uomo che cerchi di raccontare una storia a un amico. Ma dimentica una parola su quattro, parole generalmente molto semplici come automobile, via, poliziotto. Farfuglia, esita, gesticola, cerca degli equivalenti patetici, fino a quando l’amico, irritatissimo, lo schiaffeggia e se ne va.” (Buñuel all’altezza di sé stesso anche nelle scene non girate).
E dunque: infanzia nel medioevo, studi dai Gesuiti, residenza universitaria a Madrid con le peñas nei Café letterari come il Gijon, il Castilla, il Kutz. L’amicizia con l’elegantissimo Federico García Lorca – cravatta impeccabile, aura magnetica, la sua camera alla Residenza diventò il più ambito salotto culturale della città. Buñuel gli faceva da barista, preparando proibitissimi grog al rum, mentre nel tempo libero si dava al banjo, all’ipnotismo e ai travestimenti. E poi il sodalizio con Salvador Dalí, soprannominato “pittore cecoslovacco”. Voce grave, capelli lunghi e timidezza patologica, quando si presentò all’esame di Belle Arti si sedette davanti alla commissione e stupì tutti affermando: “Non riconosco a nessuno di voi il diritto di giudicarmi. Me ne vado”.
Poco prima del lungo soggiorno parigino, l’istituzione del cosiddetto Ordine di Toledo. Un’idea che al regista venne in sogno – in tutta evidenza, Buñuel era già il Surrealismo. La Confraternita contemplava una gerarchia molto rigida. Per essere caballero bisognava amare Toledo senza riserve, bere per una notte intera e girovagare senza meta per le strade della città. Chi non avesse voluto, poteva al massimo ambire alla carica di scudiero. I membri erano soggetti a due regole rigidissime: contribuire con dieci pesetas alla cassa comune e partecipare a tutte le attività che venivano proposte – un catalogo di stupidaggini sublimi, ciurmerie e letture notturne di poesie per la strada, svegliando i dormienti. Una notte i membri della Confraternita incontrarono un cieco che li portò a casa sua: una famiglia di ciechi, che vivevano al buio, e alle pareti, immagini di cimiteri, tombe, cipressi. Buñuel sciolse la Confraternita dieci anni dopo. Durante la guerra civile un membro rischiò di essere assassinato da un gruppo di anarchici che avevano ritrovato un documento in cui gli si riconosceva l’iscrizione all’Ordine, e se la passò malissimo finché non fu in grado di dimostrare la sua estraneità all’aristocrazia.
La biografia di Buñuel pullula di episodi che sembrano tratti da un film di Buñuel, questo perché vita e arte si parlano, se uno se lo merita. E la Parigi dei tempi andati, “quando eravamo molto poveri e molti felici” – lo scrisse Hemingway in Festa mobile, uno dei libri che ti fanno più rammaricare di non esserci stato, e del resto Woody Allen girò “Midnight in Paris” per sopperire alle ingiustizie dell’anagrafe, film in cui lo stesso Buñuel compare in una scena spassosissima –, quella Parigi lì, la Parigi del 1925, evidentemente si meritava tutta la popolazione artistica che ne avrebbe animato le strade e i Café, con la sua atmosfera irripetibile. In quella Parigi viveva Robert Goffin, il primo che si avvicinò al jazz per studiarlo e fece uscire, nel 1924, un testo mitologico per gli intenditori, intitolato “Jazz Band” – dieci anni dopo fonderà l’Hot Club de France, sancendo ufficialmente che in Europa sarebbe stata proprio la capitale francese a essere patria d’azione di un genere musicale fino a quel momento indagato solo come fenomeno folklorico. Nel quartiere Odéon era stata da poco aperta la libreria Shakespeare and Company dall’americana Sylvia Beach – “belle gambe e viso vivace, occhi vivi come bestiole e allegri come quelli di una bimba”, la descrisse Hemingway, che non finirà mai di ringraziarla per avergli fatto scoprire Turgenev. In quella Parigi trionfavano le gallerie, i teatri, i locali notturni, e le brasserie erano epicentri culturali. In quella Parigi arrivava dagli Stati Uniti la danzatrice Joséphine Baker, col charleston indiavolato della “Revue Nègre”, diventando in quattro e quattr’otto la star delle notti degli Champs Elysées e rendendo di colpo desiderabile l’abbronzatura – anche le signore di una certa età si rosolavano al sole sulle spiagge di Deauville.
In quella Parigi Marcel Duchamps aveva mollato tutto per occuparsi di scacchi, riuscendo comunque a far parlare di sé – tra un arrocco e un fianchetto girò il cortometraggio “Anémic Cinéma”, pietra miliare Dada e copyright di Rrose Sélavy, il suo alter ego femminile reso immortale da Man Ray. In quella Parigi, nel memorabile 1925 dell’Esposizione, col pieno trionfo dell’Art Déco, arrivò anche Luis Buñuel, ex provinciale di Calanda, un paesino dell’Aragona che contava “due chiese e sette preti” e che era nota per i tamburi del venerdì santo – andavano avanti tutta notte finché, all’alba, la pelle dei tamburi era macchiata di sangue. Il padre era morto l’anno precedente e aveva lasciato in eredità ingenti disponibilità economiche, accumulate grazie a una ferretería a Cuba, un bazar in cui si poteva comprare di tutto, dalle spugne alle armi. Se n’era tornato nella Spagna natia poco prima dell’indipendenza dell’isola e aveva comprato terreni. Su uno di questi aveva costruito La Torre, residenza estiva dotata di giardino lussureggiante, corso d’acqua privato, stagno navigabile. Un tenore di vita che rese possibile una carriera cinematografica. Cominciata proprio nella Parigi di Festa mobile. Ma attenzione, il capitolo parigino di Buñuel, che nella sua autobiografia conta poco più di dieci pagine, supera in vivacità e atmosfera, da solo, l’intero album hemingwaiano.
Quando Buñuel arrivò nella capitale francese, si stabilì all’hôtel Ronceray, lo stesso in cui era stato concepito. Cinquantadue anni dopo chiuderà il cerchio, il set dell’ultima scena che girerà sarà proprio quello. “Tre giorni dopo il mio arrivo”, racconta il regista, “venni a sapere che Unamuno era a Parigi. Alcuni intellettuali francesi, noleggiando un battello, lo avevano portato via dal suo esilio alle Canarie”. Fu proprio insieme a lui, al Café La Rotonde, che Buñuel prenderà contatto con quelli che la destra francese chiamava con disprezzo “gli stranieri”. Dopo poche settimane si beccò una fortissima influenza e un amico gli consigliò la cura dello champagne. “Detto, fatto. E scoprii anche le ragioni del disprezzo della destra francese. In seguito a non so quale svalutazione il franco aveva subito un collasso. Le monete straniere permettevano di vivere da signori. Per una bottiglia di champagne, solo undici franchi, cioè una peseta”. Nota: l’influenza passò, e Buñuel prese a frequentare il cabaret cinese adiacente all’hôtel in cui soggiornava. L’entraîneuse attaccò bottone e lui scoprì che “si esprimeva benissimo, con un senso sottile e spontaneo della conversazione, benché non parlasse di filosofia e di letteratura”. Ma gli offrì un’esperienza indimenticabile: scoprire “un nuovo rapporto tra il linguaggio e la vita”.
Vita a Montparnasse, epicentro di quasi tutto, in ghette, gilet e bombetta – quando scoprirà che gli unici senza berretto venivano tacciati di essere dei pederasti, getterà il suo per sempre. Vita notturna a far su e giù, rimbalzando dal Dôme a La Rotonde, da Le Select all’hôtel Mac-Mahon per ascoltare il jazz, o a ballare allo Château de Madrid. Ma non tutto luccicava, nemmeno nella Parigi migliore che la storia abbia prodotto. “L’antisemitismo l’ho scoperto in Francia. Gruppi di destra come i Camelots du roi e Jeunesses Patriotiques organizzavano dei raid a Montparnasse”, racconta Buñuel. Il cui esordio da regista, nel frattempo, avvenne nel seminterrato del Select. “Avevo scritto un lavoro teatrale, dieci pagine in tutto. Si chiamava Amleto”. Poi diresse una commedia di burattini ad Amsterdam – Buñuel volle attori travestiti da burattini anche tra il pubblico – e il cortometraggio “Un chien andalou”. Girato il quale, uno scrittore che pubblicava su Les Cahiers d’Art pensò di presentargli quello strambo di Man Ray, che aveva appena finito di girare un documentario su un castello e aveva bisogno di un supplemento al programma di proiezione – anche le coincidenze, bisogna meritarsele. A La Coupole, i due cenarono insieme a Luis Aragon, che si presentò “con tutta la grazia delle maniere francesi”. Il giorno dopo videro la versione integrale allo “Studio des Ursulines”, lo battezzarono con entusiasmo come surrealista e dissero che bisognava mostrarlo a più gente possibile. Ma cos’era il Surrealismo, in quel momento così seminale eppure decisivo? “Qualcosa nell’aria”, scrive il regista. “Una specie di appello raccolto da gente che praticava una forma d’espressione istantiva e irrazionale, prima ancora di conoscersi e riconoscersi. L’incontro con il gruppo fu essenziale e decisivo per tutto il resto della mia vita”.
I Surrealisti si riunivano al Café Cyrano, in place Blanche. Un locale piuttosto popolare, a Pigalle, tra puttane e magnaccia. Si leggeva, si discuteva. Si immaginava un’azione esemplare da compiere. C’erano Max Ernst e André Breton, Paul Eluard e Tristan Tzara, Jean Arp e Magritte. Presenziarono tutti, in massa, alla prima del film di Buñuel. Inviti a pagamento, la crema delle società parigina – tra il pubblico, Picasso, Le Corbusier, Cocteau, e dietro lo schermo, a maneggiare il grammofono, un terrorizzato Luis Buñuel, che faceva suonare tanghi argentini e brani da “Tristano e Isotta”. In tasca, manciate di sassi. “Per gettarli sul pubblico, nel caso in cui avessi fatti fiasco. Ero preparato al peggio”. Alla fine della proiezione ci fu un lungo applauso. Buñuel si liberò con discrezione dei suoi proiettili. “Il vero obiettivo del Surrealismo”, ricorderà, “non era creare un nuovo movimento, ma far esplodere la società. Eravamo quasi tutti borghesi che si ribellavano alla borghesia. Io ne ero un esempio. L’idea di incendiare un museo mi ha sempre allettato più dell’apertura di un centro culturale. La nostra morale era un’altra. Esaltava l’insulto, la mistificazione, la risata nera, il richiamo degli abissi. La nostra morale era più esigente, più pericolosa, più coerente di qualsiasi altra”. E poi i Surrealisti erano belli. “La bellezza luminosa e leonina di Breton. La bellezza preziosa di Aragon. Max Ernst, col suo straordinario volto da uccello”. Tutti ardenti, fieri, indimenticabili, in una Parigi che non si ripeterà più.
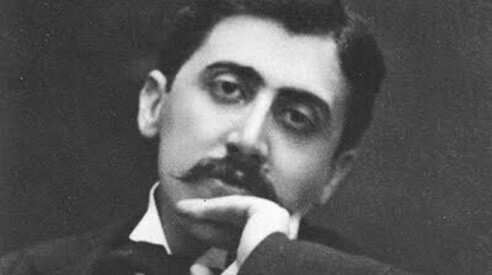

Amleto e miss Marple
Indomabile. È un romanzo sulla vita della ragazza che inventò il mistero
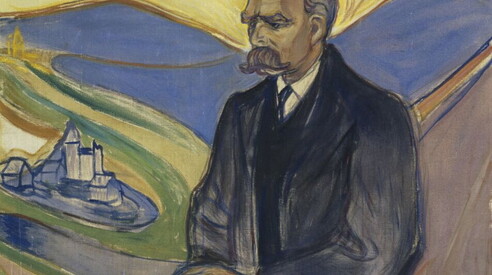
scrollarsi di dosso il passato per guardare al futuro


