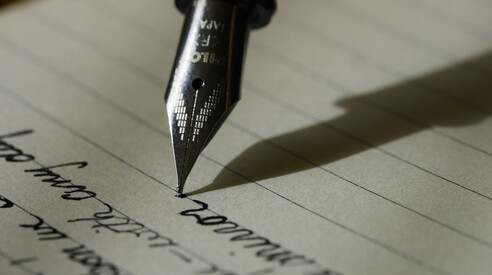
Foto di Aaron Burden su Unsplash
la prospettiva
L'arte, ovvero l'accesso a versioni meno ovvie della realtà. Rileggere Šklovskij
La concezione artistica offre una visione non ovvia, anzi straniata, dalle situazioni quotidiane, costringendoci a indugiare su ciò che di solito sorvoliamo in fretta. L'autore del formalismo critico indaga le leggi interne dell'arte
Lo scrittore russo Viktor Šklovskij, nato nel 1893 e morto nel 1984, è stato a vent’anni un protagonista dell’Opojaz, la Società per lo studio della lingua poetica di San Pietroburgo, che con il circolo moscovita di Jakobson partorì il formalismo critico che indaga le “leggi interne” dell’arte, ovvero, per dirla con una sua metafora, lo studio che non s’interessa “della situazione del mercato mondiale del cotone, e neppure della politica dei trust, ma solo del tipo di filato e dei modi di tesserlo”. Šklovskij partecipa agli eventi del 1917 da socialista rivoluzionario, restando lontano dai bolscevichi, e nel 1922, sfuggito a un attentato della Ceka, ripara a Berlino. E’ il tempo di “Zoo o lettere non d’amore” e del “Viaggio sentimentale”, che sulla guerra ha pagine paragonabili nel 900 solo a quelle di “Omaggio alla Catalogna”. Col loro misto di autobiografia e teoria, con la rapidità brusca dei passaggi e le similitudini tenere o futuristiche, questi libri non sono troppo diversi – per forma, appunto – da “Teoria della prosa”, il volume del ’25 in cui l’autore, rientrato in patria dopo la malinconica accettazione del potere sovietico, riunisce i suoi saggi giovanili: saggi sul legame tra intreccio e stile, sul “Don Chisciotte” e il “Tristram Shandy”, sulla letteratura del mistero… E’ nella “Teoria”, oggi ripubblicata da Quodlibet, che Sklovskij illustra il concetto di “straniamento”.
L’arte, dice, è il contrario dei simboli algebrici che “imballano” gli oggetti inaridendo la percezione: ci offre cioè una versione non ovvia, e anzi straniata, delle situazioni quotidiane, costringendoci a indugiare su ciò che di solito sorvoliamo in fretta. Il concetto è nell’aria: lo si ritrova applicato, ad altre latitudini e con altri gerghi, nella poetica della metafisica dechirichiana, in Kafka e in Proust. Ma Šklovskij prende i suoi esempi da Tolstoj, che sarà sempre la sua pietra di paragone, e che a suo avviso descrive ogni oggetto di rilievo “come se lo vedesse per la prima volta”. Per farlo “adopera nella descrizione dell’oggetto non le denominazioni abituali delle sue parti, bensì quelle delle parti corrispondenti in altri oggetti”: si pensi alla vita umana vista da un cavallo nel racconto “Kholstomer”, al teatro descritto in “Guerra e pace”, o al tribunale di “Resurrezione”. Ai fini dello straniamento, conta il lavoro compiuto su tutti i piani tecnici. La rima e la simmetria psicologica delle figure, le costruzioni narrative a gradini e quelle ad anello, possono ugualmente contribuire al contenuto dell’opera, il quale non è altro che la somma dei suoi procedimenti in senso ampio stilistici. Il critico parla dei testi con lo stesso fervore con cui parla delle macchine da guerra che ben conosce: si tratta sempre di smontare e rimontare pezzi. Il tema della poesia sta diventando la poesia stessa; e presto il tema della teoria sarà la teoria, con la poesia come puro pretesto.
E’ l’epoca dell’accelerazione avanguardistica, che fa apparire tutto il moderno come una parodia, e l’intera storia estetica come una rapidissima lotta di poetiche che vincono, sfumano, ritornano sottotraccia e magari si riprendono il centro del panorama dopo molte stagioni. Non a caso l’autore di “Teoria della prosa” ama Sterne, che già all’alba della storia del romanzo – il genere nato dalle novelle a cornice – fa dell’infrazione formale il suo vero tema. Victor Erlich osserva che la teoria sklovskiana regge meglio in questi casi-limite: comprende di più, cioè, il “Tristram Shandy” del “Don Chisciotte”, in cui la dialettica tra pazzia e saggezza non è solo un espediente tecnico ma un dilemma filosofico. In ogni caso, finito l’800, la grande età dell’intreccio preso sul serio si è chiusa per tutti, e Šklovskij cerca una via d’uscita in due poli opposti d’interesse: da un lato la prosa ornamentale, dall’altro il giornalismo, il montaggio da varietà e da cinema, il materiale grezzo dei taccuini. Lui stesso ci offre esempi concreti, passando di continuo dal diario al reportage, e dalla narrativa a quella critica che è a sua volta arte, dato che deve descrivere le opere rimuovendo gli automatismi della nostra percezione impigrita dai manuali. Paradossalmente, i meno consapevoli di questo statuto “non teorico” della teoria saranno proprio gli epigoni del pioniere russo, cioè gli studiosi strutturalisti degli anni 60. A differenza dei loro testi, “Teoria della prosa” non è un libro per specialisti: perché non si può mai essere specialisti in letteratura, nemmeno se si ha la vocazione al formalismo.



Salvate il soldato Paz


