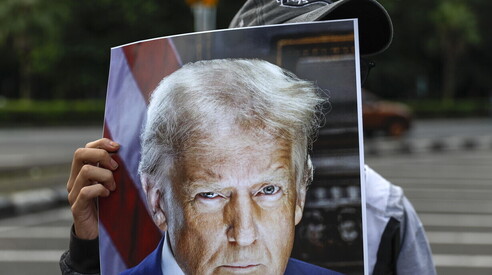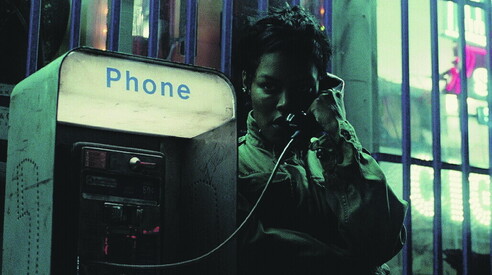Foto di Frank Tunder su Unsplash
lo scrittore
Dino Campana, il versatore vagabondo ossessionato da Nietzsche
Un poeta errante e tormentato, colto e modernissimo, ossessionato da Nietzsche e in costante dialogo con la cultura europea. Campana è stato un lettore vorace e spirito lucido, capace di fondere sensibilità romantica, visione filosofica e inquietudine moderna nei suoi indimenticabili Canti Orfici
Quando è nato lo smartphone qualcuno su Reddit chiese agli altri utenti: “Se di colpo apparisse qualcuno degli anni ’50, quale sarebbe la cosa più difficile da spiegargli della vita contemporanea?”. La risposta più quotata, diventata in sé una sorta di meme della internet culture, fu: “In tasca possiedo un device capace di accedere alla totalità delle informazioni note all’uomo. E lo uso per guardare foto di gatti e per litigare con gli sconosciuti”. Ecco, grazie a Mondadori, esiste un parallelepipedo poco più grande di un iPhone – e sicuramente meno costoso – che contiene la totalità della produzione letteraria di Dino Campana. In più ha quell’odore unico dei Meridiani – la Yankee Candle dovrebbe farne una versione per le sue candele da salotto country chic – che nessun prodotto immaginato da Steve Jobs potrebbe avere. Ma annusate cartacee a parte, L’opera in prosa e in versi riempie un vuoto anche letterario, tenendo insieme tutto ciò che di scritto ci è rimasto del poeta maledetto di Marradi.
Ma appunto, il maudit Campana era molto più di quello, non solo un talentuoso versatore vagabondo che ha passato la vita tra il girovagare tra Genova, Livorno e l’Argentina e i manicomi (dove poi è morto a 46 anni, nel 1932). Come ci racconta nella prefazione il curatore Gianni Turchetta, Campana è stato un grande lettore, e un uomo che ha saputo cogliere le pulsioni culturali del suo tempo, o sfidarle, come è il caso della sua critica a d’Annunzio.
In una lettera a Prezzolini definisce il vate un “poveraccio” che “dell’Europa moderna non capisce proprio nulla”. Come scrive Turchetta, se per d’Annunzio il poeta è un essere superiore, per Campana “l’arte è il sofferto strumento di una conoscenza suprema, sì, ma che non pretende mai di farsi mosca cocchiera della politica”. Campana non è un “saggio ignorante di montagna”, per citare Guccini, un mezzo barbone che ubriaco butta giù rime, ma un attento conoscitore della sua epoca. Campana passava le giornate in biblioteca e leggeva in inglese, in francese e in tedesco le riviste, tenendosi costantemente aggiornato. Era un grande fan di Edgar Allan Poe. Passava dalla Bibbia di Lutero alle Stones of Venice di Ruskin, dai romanzi sociali di Zola a Walt Whitman – l’unico libro che si porta in Sudamerica è proprio Foglie d’erba. Si interessa alla pittura, dal rinascimento italiano fino a Carrà. E poi Nietzsche. E’ anche attraverso la sua lente che riprende il mito di Orfeo e la sua tradizione plurimillenaria unendo, come diceva Asor Rosa, “la civilisation francese con la Kultur tedesca”. Di Nietzsche, scrive Montale, Campana aveva una “conoscenza sicura e spesso ossessiva”.
L’eterno ritorno”, dice il curatore del Meridiano, è “un vero e proprio paradigma strutturante dei Canti Orfici”. Certo, resta il fatto che Campana fosse un precario, saltellante tra treni e mestieri non qualificati, dentro e fuori cliniche e manicomi, prono a scatti d’ira, e ci rendiamo conto della sua irrequietezza, come della sua cultura, anche leggendo le lettere presenti nel volume, in coda ad alcune delle più splendide poesie del novecento italiano. Si definisce “solitario ombroso” e dice “io credo che chi sia ricco di vita interiore non debba arrendersi al primo assalto”. In una lettera a Papini si firma L’homme des bois, ma anche lui sa di esser molto più di questo.