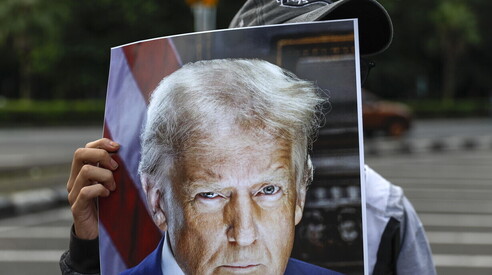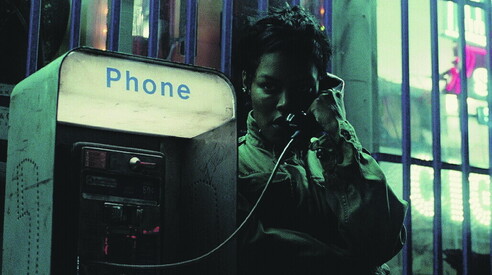Antonio del Castillo y Saavedra, “San Tommaso d’Aquino”, olio su tela, 1600-1649, Museo delle Belle arti di Cordova
Il miracolo del dubbio
Tommaso d'Aquino, altro che teologo senza ripensamenti
Papa Giovanni XXII, convinto della santità del frate, dichiarò: “Ha fatto tanti miracoli quanti articoli ha scritto”. Il dubbio è veramente una grazia di Dio. La lezione medievale contro gli intellettuali fanatici
Interessanti gli atti del processo di canonizzazione di san Tommaso d’Aquino: alla domanda sullo stato di salute di un miracolato prima del miracolo, due testimoni risposero che questi camminava con l’ausilio di stampelle, tre dissero, invece, che non era affatto in grado di camminare e che si fece portare al monastero di Fossanova sorretto da due uomini. Insomma: camminava, seppur con le stampelle, o non camminava? Comunque, lì, presso la tomba di fra’ Tommaso d’Aquino, dissero, lo zoppo prese d’un tratto a camminare sulle sue gambe: miracolo, gridarono tutti, e si misero a cantare il Te Deum. “E quando sarebbe avvenuto questo miracolo – chiese loro il notaio – di giorno o di notte?”: un testimone rispose “di mattina”; un altro “tra la mattina e il pomeriggio”; due risposero “di pomeriggio”, e l’ultimo sentenziò sicuro: “al tramonto”. Risposte diverse come il giorno e la notte. “Ricordate almeno l’anno del miracolo?” fu chiesto loro a quel punto: “Non ricordo” risposero due testimoni; gli altri tre invece lo ricordavano bene, dichiararono, solo che ognuno indicò, sicuro, un anno diverso: 1279, 1281, 1282. Insomma, come ha notato Paolo Mariani (Racconto spontaneo o memoria costruita? in “Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age”, 108, 1, 1996, pp. 259-319), “dal vuoto di memoria al massimo di precisione auspicabile” e sempre nessuna concordanza.
I dubbi sull’attendibilità dei testimoni e sul miracolo in questione sarebbero venuti a chiunque.
Vennero infatti persino a uno dei due frati domenicani incaricati di raccogliere le testimonianze per il processo, Roberto da Benevento, il quale a un certo punto voleva ritirarsi da un’impresa che gli sembrava poco trasparente. Manco il tempo di tornare al convento, però, che fu colto da “diarrea, febbre, perdita di appetito e insonnia”. A quel punto Guglielmo da Tocco, l’altro frate, uomo molto determinato, lo convinse che tutti quei sintomi erano chiaramente un miracolo punitivo da parte dell’anima di Tommaso d’Aquino. Così, il povero fra’ Roberto, terrorizzato, riprese senza indugio il suo lavoro, e fra’ Guglielmo da Tocco fu felice di inserire nella lista dei miracoli del suo dossier per il processo di canonizzazione sia il miracolo dello zoppo guarito – e al diavolo la discordanza fra i testimoni – sia quello della influenza intestinale punitiva. Tra parentesi: non immaginavo che esistessero pure miracoli punitivi.
Presso la tomba di fra’ Tommaso lo zoppo prese a camminare sulle sue gambe: miracolo, gridarono tutti, e si misero a cantare il “Te Deum”
Fra’ Guglielmo doveva essere proprio ostinato nella sua ricerca di miracoli di Tommaso. Andrea Tilatti (La canonizzazione di Tommaso d’Aquino come crocevia di intenzioni eterogenee, in V. S. Doci – G. Festa, a cura di, Fra trionfi e sconfitte: “politica della santità” dell’Ordine dei predicatori, Angelicum University Press, Roma 2021, pp. 61-83) racconta un episodio divertente. Sembra che il fabbro del monastero di Fossanova, a cui fra’ Guglielmo aveva chiesto con insistenza di ferrare con sollecitudine i muli, ebbe a sbottare testualmente: “Quanto ci molestano e ci tormentano questi frati predicatori a causa di questo frate Tommaso. Se è stato un uomo così santo, che faccia un grande miracolo: che questi frati predicatori se ne vadano e non rimangano qui più a lungo”. A quel punto, fra’ Guglielmo ritenne di dover informare dello spiacevole episodio il Cielo, il quale immantinente inviò al fabbro, manco a dirlo, un miracolo punitivo: un lancinante dolore al braccio destro, che scomparve solo dopo pentimento e preghiera allo stesso fra’ Tommaso.
Naturalmente non tutti i miracoli furono di questo tipo: Guglielmo da Tocco ne raccolse altri riguardanti diverse guarigioni a povere persone ammalate. Tuttavia, è noto che essi non erano né molti né a quanto pare sempre del tutto convincenti, tanto che il processo di canonizzazione ebbe una battuta d’arresto e fu richiesta una terza indagine supplementare. A un certo punto, però, sembra che Papa Giovanni XXII, già convinto (dal suo amico il re d’Angiò) della santità di Tommaso, mise la parola fine a qualsiasi perplessità con le parole, riportate in seguito da altri: “Ha fatto tanti miracoli quanti articoli ha scritto”.
Insomma: gli articula valevano come miracula, a tal punto erano chiari, profondi, ricchi di solidissima dottrina, certamente ispirata da Dio. E’ sempre Guglielmo da Tocco a scriverlo: “Segno della sicurezza del suo giudizio fu il fatto che le nuove teorie e le argomentazioni che scrisse quando era baccelliere non modificò nel suo insegnamento e nemmeno nei suoi scritti una volta divenuto maestro (…). Il nostro dottore sfavilla per la sua dottrina divinamente ispirata” (Guglielmo da Tocco, Storia di san Tommaso d’Aquino, a cura di D. Riserbato, Jaca Book, Milano 2015, p. 151-152). Il miracolo, insomma, che viene fuori dagli articoli, sarebbe quello di una dottrina sempre coerente, uniforme, compatta, mai cangiante, sicura, ispirata da Dio: nessuna incertezza, evoluzione, ripensamento, cambiamento di opinione. In effetti è questa l’immagine di Tommaso, creata ad hoc da Guglielmo da Tocco, che è giunta praticamente intatta fino ai nostri giorni. E’ un’immagine che corrisponde alla realtà? E’ lecito farsi qualche domanda sul miracolo degli articoli ispirati, uniformi e mai modificati?
I pochi manoscritti autografi di Tommaso che ci sono pervenuti sono stati riscritti da lui fino a quattro volte e non si tratta di piccole correzioni su argomenti di minor importanza. I primissimi commentatori dell’opera di Tommaso – lo ricorda tra gli altri Giorgio Pini (The Development of Aquinas’s Thinking, in B. Davies – E. Stump, eds., Oxford Handbook of Aquinas, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 491-510) – in una serie di scritti, detti “migliori detti”, annotarono diversi temi in cui Tommaso avrebbe detto meglio nelle sue opere della maturità rispetto all’opera giovanile Commento alle Sentenze, insomma diversi cambiamenti di opinione: ne contarono ottanta. Il Dottore Angelico ebbe dubbi e ripensamenti.
Li ebbe, ad esempio, sul rapporto fra la volontà e l’intelletto umano. In alcuni articoli sostenne che la volontà segue la ragione, sicché la scelta del male dipenderebbe da un giudizio errato della ragione su ciò che è bene o è male. Insomma, il male sarebbe compiuto, lo aveva detto già Socrate, per ignoranza del bene. In altri articoli, tuttavia, ritenne invece che la volontà non segue sempre la ragione: è autonoma. Di conseguenza, la scelta del male non dipenderebbe da un errore di giudizio intellettuale ma dalla libertà della volontà, capace di scegliere il male pur sapendo (con la ragione) che è male. Come si nota, articoli e dottrine distavano tra loro come l’intellettualismo dal volontarismo. E difatti gli studiosi disputano ancora se annoverare Tommaso fra i seguaci dell’una o dell’altra corrente. Forse, semplicemente, Tommaso riconosceva le ragioni degli uni e degli altri.
Prendiamo la questione delle anime dei defunti. Come farebbero a conoscere, a farsi un’idea delle preghiere dei viventi, visto che in vita ci si può fare un’idea di qualcosa solo se si riesce a visualizzarla, ad averne una immagine sensibile? In alcuni articoli Tommaso sostenne, come Platone, che la nuova situazione non sollevava problema alcuno, visto che l’anima umana non è legata per natura al corpo e quindi non è dipendente necessariamente dai sensi: senza il corpo, dunque, nell’al di là, l’anima conoscerebbe ancora meglio. In seguito, invece, in altri articoli, egli sostenne, come Aristotele, che l’anima umana è legata per natura al corpo e ai sensi, e dunque non è affatto in grado di conoscere alcunché senza il corpo. E quindi come farebbero le anime dei defunti a conoscere le cose di questo mondo, ad ascoltare e farsi un’idea delle preghiere dei viventi a loro rivolte? Solo con l’aiuto di Dio, rispose Tommaso. In ogni caso, è evidente che vi fu un’evoluzione nel suo pensiero, come ha mostrato Giorgio Pini: dal platonismo (l’anima non è legata al corpo) all’aristotelismo (l’anima è legata al corpo), a lui più congeniale. Tra parentesi: come fanno i teologi a descrivere minuziosamente, e addirittura a litigare, su cose del tutto non verificabili come il tipo di conoscenza che hanno le anime dei defunti delle cose di questo mondo? Che ne sanno?
Ma torniamo a Platone e Aristotele. Esistono le idee platoniche in sé e per sé? In alcuni articoli Tommaso, seguendo Aristotele, lo negò risolutamente: non esiste nessun mondo delle idee, esiste solo il mondo degli individui, unici e irripetibili, come Achille, Socrate e Maria. Tuttavia, lo stesso Tommaso scrisse in altri articoli che la dottrina di Platone era “verissima e consona alla fede cristiana” se riferita a Dio, che è “forma separata” ed “essere stesso separato”, tutte espressioni che più platoniche non si potrebbe. Insomma, Tommaso oscillava vistosamente tra l’aristotelismo (non esistono forme separate) – che poi era la novità della sua opera - e il neoplatonismo (Dio è una sorta di forma separata), comune anche ai teologi del suo tempo (cfr. G. Ventimiglia, Aquinas After Frege, Palgrave-Macmillan, Cham 2020, pp. 12-24, 74-82).
Scrisse che Dio non prova passioni, che sono legate al corpo. Ma poi sostenne che le passioni dell’amore e della gioia si dicono di Dio
A proposito di Dio: almeno su di Lui ebbe idee chiare e stabili? Insomma. Prendiamo ad esempio la questione se in Dio vi siano passioni. Da una parte scrisse che Dio non prova passioni, perché le passioni sono legate al corpo e Dio è puro spirito, sicché Dio amerebbe gli uomini “sine passione”, senza passione, apaticamente. Dall’altra egli sostenne che almeno le passioni dell’amore e della gioia, che non comportano nessuna imperfezione, si dicono di Dio, essere perfetto, non in senso metaforico ma in senso proprio: insomma, si può ben dire che Dio gioisce e ama con passione. Sebbene ogni volta ben argomentate, le opinioni di Tommaso non erano sempre uniformi.
E Dio? Si può sperare che almeno Lui non cambi? Certo, Egli è immutabile e immobile: Tommaso lo scrisse sempre, senza cambiare mai idea, negli articoli dedicati a questo argomento. In proposito, insomma, non ci piove. O meglio: ogni tanto sì, e meno male. Perché le traduzioni dall’arabo in latino delle pagine che il suo stimatissimo Aristotele aveva dedicato a Dio, atto puro, riportavano il termine “actio” (azione) invece di atto, e difatti Tommaso scrisse che Dio, atto puro, è attività, in particolare è attività di conoscere e amare, e, aggiunse, l’attività comporta un certo “motus”. D’altra parte, proseguì, se Dio è vita, qualche cambiamento in Dio vi deve pur essere. E forse qui Tommaso, invece che al suo maestro domenicano Alberto Magno, strenuo difensore dell’immutabilità di Dio, tornò indietro con la memoria al suo primo maestro a Napoli, Pietro l’Irlandese, quello dei suoi studi giovanili, il quale aveva sostenuto che in Dio vi sono “passione, movimento e mutamento”. Insomma, in alcuni articoli Dio è considerato immutabile, in altri egli è concepito come vivo, attivissimo e in un certo senso in movimento.
Riassumo, parafrasando Woody Allen: Dio non è del tutto immutabile, Tommaso cambiò opinione, e anche noi a questo punto non ci sentiamo più tanto sicuri di nulla. Certo, perché la stabilità è rassicurante, mentre il cambiamento e il dubbio non lo sono.
Tommaso cambiò opinione, e anche noi a questo punto non ci sentiamo più tanto sicuri di nulla. Ma il dubbio è veramente una grazia di Dio
Eppure, mi sembra, quando imperversano i fanatici di ogni tipo, sicurissimi di mille certezze – succedeva al tempo di Tommaso e succede ancora oggi – il dubbio è veramente una grazia di Dio. Quando tutti si ostinano caparbiamente e dogmaticamente a restare inamovibili nelle loro opinioni – siano essi, oggi, ad esempio i credenti tradizionalisti o gli atei progressisti, gli intellettuali di destra o di sinistra, gli scientisti e i negazionisti – qualcuno capace di cambiare idea, o anche di rimanere nel dubbio di fronte a due tesi ben argomentate ed egualmente plausibili, è un esempio di onestà intellettuale, un testimone autentico di ricerca della verità.
Al tempo di Tommaso d’Aquino le lezioni universitarie erano organizzate in forma di questioni, di domande, su temi spesso chiamati “dubitabilia”, ossia precisamente suscettibili di dubbio, e infatti iniziavano tutte con un “se”. E’ il caso persino della lezione sull’esistenza di Dio che recitava: “utrum Deus sit”, se Dio esista. Vuoi vedere che i medievali erano meno dogmatici di noi moderni? Questo non vuol dire, ovviamente, che dominava l’incertezza e il relativismo, per nulla, ma la fede non eliminava il dubbio, al contrario generava la cogitatio, la ricerca, il desiderio genuino di capire e quindi suscitava domande. Lo ha detto pure Papa Francesco: “Una fede senza dubbi non va”. E lo aveva già scritto secoli prima il nostro Tommaso d’Aquino: “Credere comporta un’adesione ferma e in questo il credente è simile allo scienziato (…), tuttavia la sua conoscenza non è perfetta, perché le manca l’evidenza, e in questo il credente è simile a chi dubita, sospetta o esprime solo un’opinione” (Summa Theologiae, II-II, q. 2, a. 1).
Ricordo la risposta di un noto filosofo alla domanda di uno studente: “Perché ha iniziato a studiare filosofia?” – “perché ho capito che la filosofia è l’arma più potente per aver ragione”. Ecco, un intellettuale così dubbi non ne ha, perché il suo scopo non è cercare la verità ma vincere e, se ammette di non sapere, perde. Tommaso d’Aquino inorridirebbe. Fra’ Guglielmo da Tocco narra, e l’episodio sembra essere vero questa volta, che Tommaso verso la fine della sua vita smise di scrivere, lasciando diverse sue opere incompiute. E al suo segretario che gli chiedeva il perché di questa drastica decisione, ebbe a dire: “tutto quello che ho scritto mi sembra paglia”. Un intellettuale ossessionato dall’aver ragione, dall’esigenza di vincere, incapace di dubbi, non lo avrebbe mai detto. Tommaso invece sì. Certo, era dotato di un’intelligenza eccezionale: scrisse qualcosa come un milione di parole, circa diecimila pagine di stampa moderna, straordinariamente interessanti, su quasi tutto lo scibile. Eppure, san Tommaso d’Aquino ebbe il senso del limite, sperimentò il mistero di Dio e anche quello del mondo. Sapeva davvero di non sapere. E proprio questo a me sembra il suo miracolo più vero e più bello.
P.S. Ad alcuni tomisti il mio articolo non piacerà, ché i dubbi e i ripensamenti di Tommaso mettono in crisi il loro bisogno di sicurezza e le loro finte certezze sulla monoliticità della sua dottrina. Forse pregheranno Dio, come fra’ Gugliemo da Tocco, che mi mandi qualche miracolo punitivo. Facciano pure, tanto non esistono.
Giovanni Ventimiglia è professore di filosofia all’Università di Lucerna e all’Università di Zurigo. Ha all’attivo più di cento pubblicazioni (in italiano, inglese e tedesco), molte delle quali su Tommaso d’Aquino. La città di Roccasecca, luogo natale del santo, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua nascita, gli ha conferito il premio san Tommaso d’Aquino. La cerimonia di consegna si svolgerà il 18 luglio prossimo.