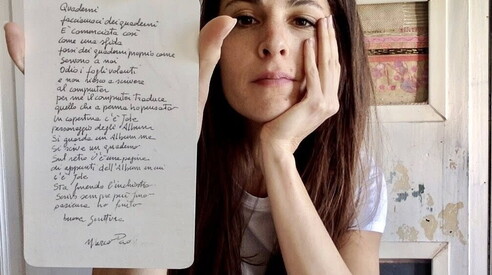facce dispari
Massimo Popolizio: “Con il teatro mi regalo una inattualità felice”
"Non vendiamo tappeti". L’attore e regista contro retorica, social e politically correct. Di nuovo sulle scene con "Ritorno a casa" mentre prepara uno spettacolo su Umberto Orsini: "Il teatro è una medicina, ma bisogna meritarselo. Basta autocelebrazioni". Dal rifiuto dell’overtourism a Simenon. Intervista
Si considera felicemente “anacronistico” Massimo Popolizio, e non se ne compiace ma ci si diverte. Per esempio mettendo in scena e interpretando una commedia politically incorrect di Harold Pinter sulle dinamiche della famiglia: “Ritorno a casa” ha esordito il 7 maggio a Roma al Teatro Argentina dove resterà fino al 25. Quarantott’ore dopo, il 27, Popolizio s’immergerà nelle prove di “Prima del temporale” di cui curerà la regia, dedicato alla lunga biografia artistica di Umberto Orsini (che impersonerà se stesso), con debutto a Spoleto il 27 giugno. L’essenza cancerina – Popolizio è nato il 4 luglio – spinge a scavare nel passato anche coloro che non credono all’astrologia. È una corrida con le nostalgie, in cui i ricordi vanno tramutati in risorse per non restarne trafitti.
Fare l’attore aiuta o sfavorisce?
Questo mestiere logora una certa sfera emotiva che la rappresentazione di tanti personaggi mette sempre in gioco e che mi piace paragonare alla schiena dei tassisti o ai piedi dei ballerini. Però fare teatro è anche una medicina che preserva dagli assilli della quotidianità: quando sei in tournée è faticoso, ma sei racchiuso in una bolla in cui non pensi al condominio, al parcheggio, alle bollette. Condividi l’esperienza con un gruppo di persone che diventano la tua famiglia momentanea. Mangiare assieme, prendere l’albergo, cambiare continuamente città. È ancora come si faceva un tempo. Un salutare anacronismo in un mondo sempre più virtuale.
Si sente anacronistico?
Sì se vuol dire non amare l’overtourism, i social, gli spritz. Talvolta, lo confesso, non capisco pienamente i giovani come mio padre non capiva me. Insegno in accademia e non mi piace cavarmela con la retorica di chi dice: “Voglio trasmettervi la mia esperienza”, perché ognuno deve farsi la sua. Cerco piuttosto di trasferire un nucleo di vitalità professionale, quel vigore di cui i ragazzi avranno bisogno.
Un consiglio prezioso?
Coltivare l’umiltà. Non è banale oggi che già a sette anni i figli dominano i genitori e che il rispetto per gli altri, nelle minime interazioni, sembra quasi un di più. Quando ero piccolo c’insegnavano a non usare il verbo “voglio”, a meritarci le cose. Nel teatro, fortunatamente, il merito è ancora necessario: se non sei capace non puoi fare questo mestiere, perché c’è un pubblico che giudica. Quella bellissima parola, “inclusione”, vale per la giustizia, per la sanità, ma il palcoscenico un attore se lo deve guadagnare. Non è un diritto di tutti.
Viva la sincerità.
Non a caso ho portato in scena il testo di Pinter, scritto sessant’anni fa ma attualissimo. Basta col politicamente corretto. C’è bisogno di pungere, di coltivare umorismo pure con un po’ di cattiveria. La reazione del pubblico mi sembra ottima ma evito l’autoelogio, che è diventato così diffuso tra autori, registi e scrittori. Non vendiamo tappeti. O non dovremmo.

S’emoziona ancora?
Continuo a provare una sana paura. Recitare per me resta sempre qualcosa di anormale, un modo di guadagnarmi la vita ma che esercito con cautela.
Come si cala in un personaggio?
Assorbo qualsiasi informazione possibile, guardo tutte le edizioni dell’opera, cerco di parlare con gli attori che hanno fatto quel ruolo prima di me. Se curo la regia di un testo tradotto lo ritraduco per me stesso per averne padronanza, anche se utilizzerò la versione di cui sono stati acquisiti i diritti.
Quale suggerisce tra gli audiolibri cui ha prestato la voce?
“Lettera al mio giudice” di Simenon, il mio romanziere preferito di cui ho letto tutto tranne i Maigret. Però mi è piaciuto molto incidere “Pastorale americana” perché la prosa di Philip Roth, con periodi lunghi e tanti incisi, ha rappresentato una piacevole avventura tecnica.
Quanto legge per sé?
Molto e solo di notte, anche ore di fila perché sono un po’ insonne. Ho appena finito tutto Fante però mi piace stare su più libri contemporaneamente. In questo momento, una nuova traduzione del “De rerum natura” di Lucrezio e “Cose che succedono la notte” di Peter Cameron.
A cosa s’appassiona quando non lavora?
Alla natura. Mi rifugio nella casa di Todi dove mi dedico agli alberi, alle rose, a lavande e rosmarini. Capisco il senso del tempo ripassando davanti a un leccio che ho piantato quando aveva un diametro di tre centimetri e ora ne misura venti. Non amo la retorica del green, però è rigenerante camminare in un bosco in santa pace e senza l’intrusione di chi va a farci trekking. È l’ultimo contatto non mediato da qualcosa o da qualcuno, una sensazione che da ragazzo provavo pure in certi angoli di Roma, in luoghi incolti che sentivo miei.
Cosa rimpiange?
La città senza B&B, le comitive dove non s’avvertivano le differenze economiche delle rispettive famiglie, gli affitti condivisi che consentivano, come nel mio caso, di andarsene di casa a diciott’anni. Abitavamo in sei in un appartamento ma potevamo permettercelo. Oggi per una stanza chiedono 700 euro e magari ne guadagni 900. È un’Italia impazzita, accessibile davvero solo a chi ha un certo reddito. I ricchi stanno coi ricchi e i poveri coi poveri. Ed è tutto tristemente incasellato e regolamentato.
Che si può fare?
Se fossi un politico imbastirei una bella risposta, ma posso solo invitare, con Calvino, a capire ciò che non è inferno e a dargli spazio. Perciò adesso preferisco il registro brillante anche a teatro: sento la voglia di sdrammatizzare e mi riesce meglio in compagnia che da solo.


Non è una "magica favola"
Il soggiorno sanremese di Čajkovskij dove nacquero la Quarta Sinfonia ed Evgenij Onegin