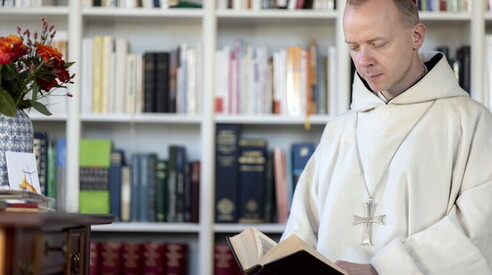Il cardinale Camillo Ruini (foto LaPresse)
Il Concilio di Ruini
“Il Concilio Vaticano II fu un momento di grazia, i problemi vennero dopo”. Intervista a Camillo Ruini
A dicembre si celebrerà il sessantesimo anniversario della chiusura del Vaticano II. Intervista all’ex presidente della Cei: “Il cambiamento culturale che spinse la secolarizzazione non dipese dal Concilio”. Leone XIV? “Ha portato pace e serenità, resta da vedere se ciò durerà e si consoliderà”
Manca poco più di un mese alle celebrazioni del sessantesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, indetto e aperto da Giovanni XXIII e chiuso cinque anni più tardi da Paolo VI. La settimana scorsa, in Vaticano, s’è celebrato il sessantesimo anniversario della dichiarazione Nostra aetate sul dialogo interreligioso, il cui cuore era rappresentato dalle relazioni fra cattolici ed ebrei. Una pietra miliare dopo secoli di incomprensioni (non di rado violente) che diede il via a un nuovo rapporto, culminato con la storica visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma, accolto dall’allora rabbino capo Elio Toaff. Si parlava, negli anni Sessanta, di primavera, il mondo cattolico era in effervescenza per qualcosa di mai visto, di imponente; un qualcosa destinato a cambiare il volto della Chiesa stessa.
Camillo Ruini nel 1965 era un giovane trentaquattrenne e quell’evento se lo ricorda bene. Sessant’anni dopo, se dovesse fare sintesi di quell’evento, cosa direbbe? “La cosa più giusta – racconta in una conversazione con il Foglio – mi sembra ripetere le parole di Giovanni Paolo II che definì il Concilio ‘la più grande grazia del XX secolo’. Ho vivo il ricordo di quegli anni: ero giovane e il Concilio ha suscitato in me gioia ed entusiasmo. Sentivo che si apriva un periodo nuovo, nel quale la Chiesa dei nostri sogni giovanili poteva diventare realtà. In particolare ero da sempre un appassionato fautore della libertà religiosa e il Concilio la approvò ufficialmente con la Dichiarazione Dignitatis humanae, che superava le posizioni precedenti, contrarie a tale libertà”.
Ma perché, a sessant’anni di distanza, il Concilio è ancora così divisivo? Assistiamo quasi quotidianamente a discussioni fra “conservatori” e “progressisti”. Ne discutono – e non di rado animatamente – perfino cattolici che in quegli anni non erano neppure nati. Si discute dei suoi documenti che all’epoca furono approvati quasi all’unanimità, senza contare le lacerazioni sul fronte liturgico. Qual è allora la ragione principale di questo scontro o, per dirla meglio, di questa dialettica animata?
“Bisogna fare una distinzione tra Concilio e dopo Concilio. Già durante il Concilio si erano certamente formate una maggioranza conciliare che potremmo chiamare ‘progressista’ e una minoranza ‘conservatrice’, ma entrambe erano unite dalla sollecitudine per il bene della Chiesa. Terminato il Concilio, nella minoranza si solidificò un gruppo, non molto numeroso ma assai pugnace, deciso a rifiutare gli insegnamenti conciliari perché non in linea con la tradizione precedente. Contemporaneamente, nella maggioranza non pochi cominciarono a contestare i testi conciliari accusandoli di contenere eccessive concessioni ai conservatori: bisognava quindi superare la lettera dei documenti nel nome di uno ‘spirito del Concilio’, di fatto aperto a qualsiasi sviluppo, anche lontano dalla tradizione ecclesiale. Fortunatamente non pochi e spesso illustri rappresentanti della maggioranza, tra cui l’allora giovane Joseph Ratzinger, si opposero a questa deriva e costituirono di fatto un terzo gruppo, favorevole al Concilio e fedele all’insegnamento della Chiesa. Questa è ancora, grosso modo, la situazione attuale”.
E perché queste tensioni sono riemerse con forza nel pontificato di Papa Francesco? Fin dall’inizio, si potrebbe dire ripercorrendo quegli anni.
“I pontificati di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano avuto un molto importante tratto in comune: tutti e tre si erano fatti carico della difesa della tradizione ecclesiale, resistendo ai tentativi di innovazioni radicali. Papa Francesco ha dato l’impressione – vera o falsa che sia – di non gradire questo ruolo. Così hanno preso nuova forza le tendenze a discostarsi dalla tradizione”.
Potrebbe essere allora proprio Leone XIV, Papa che nel 1965 aveva appena dieci anni e viveva lontano dalle dinamiche romane, a Chicago, a chiudere – superando – questa fase apparentemente eterna di discussioni e divisioni? Dopotutto, è un Pontefice che ha vissuto interamente nella Chiesa postconciliare…
“Ho già detto in altre occasioni che a mio parere Papa Leone XIV ha compiuto una specie di ‘miracolo ecclesiologico’ riportando subito, con la sua elezione, pace e serenità nella Chiesa. Resta da vedere se questo è un fenomeno destinato a durare e a consolidarsi, come mi auguro di tutto cuore, o è invece esposto a logorarsi e a venir meno man mano che il nuovo Pontefice dovrà affrontare le questioni che lo attendono”.
Eminenza, tra gli obiettivi del Concilio c’era anche quello di formare “meglio” il cattolico, rendendo più accessibile la dottrina. Obiettivo non del tutto raggiunto, vero?
“Se la sua domanda sottintende una critica al Concilio per avere mancato questi obiettivi non mi sento di concordare. Ammesso infatti che l’obiettivo non sia stato raggiunto, i motivi di ciò non sono necessariamente da imputare al Concilio stesso. Possono infatti essere molteplici, ad esempio un cambiamento culturale che abbia spinto avanti la secolarizzazione e che molto probabilmente non è dipeso dal Concilio. Entriamo qui nel regno delle ipotesi, con le quali, come è noto, non si fa la storia”.
E la Chiesa in Italia? Lei ricevette da Giovanni Paolo II il compito, negli anni Ottanta, di rilanciare la Chiesa italiana, di traghettarla in una nuova stagione. Anche di recente si è riparlato della “svolta di Loreto” del 1985, che cambiò la rotta alla Cei su mandato del Pontefice. Fu complicata anche alle nostre latitudini l’implementazione delle scelte conciliari?
“Mandare avanti la linea che ho indicato non è stato facile perché anche in Italia erano ben presenti i problemi e i contrasti a cui ho accennato. Va detto però che la situazione italiana era meno compromessa di altre, ad esempio di quella belga o di quella tedesca, e quindi è stato possibile raggiungere risultati migliori, che in questi ultimi anni mi sembrano però messi di nuovo in discussione”.
In Italia abbiamo i “cattolici adulti” che dicono di rifarsi allo spirito conciliare, rivendicano autonomia di giudizio e denunciano un “cattolicesimo di destra” che tradirebbe i valori del Vaticano II anche per le scelte politiche adottate. Lo abbiamo constatato in particolare sul finire dell’estate, dopo la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, con annessa standing ovation.
“Per la verità queste rivendicazioni mi sono in gran parte sfuggite, segno che non leggo abbastanza i giornali. Si tratta per altro di vecchie questioni alle quali sono poco interessato”.
Ma perché c’è difficoltà a sinistra (anche nelle sue espressioni cattoliche) a sintonizzarsi con quel mondo sempre cattolico che oggi vota in grande maggioranza formazioni di centrodestra? Quasi che mancasse una sorta di comprensione. Uno dei pochi a dirlo è stato Graziano Delrio, cattolico del Pd, il quale ha constatato che “Giorgia Meloni ha una strategia efficace: entra in sintonia culturale con mondi diversi dal suo. Il centrosinistra quella strategia non l’ha ancora trovata. Ma deve. Altrimenti avrà un problema, per esempio con il mondo cattolico”.
“La ragione è semplice. Esistono pur sempre in Italia, e anche tra i cattolici italiani, una destra e una sinistra e chi è di sinistra non può certo apprezzare le posizioni della destra. In questo non vedo nulla di strano o di nuovo”.