
Pugni che parlano
Due libri, due storie che squarciano il velo su uno sport bello e dannato, la boxe
L’obiettivo di questa rubrica è scegliere uno sport e, attraverso due libri di letteratura sportiva, commentarlo, studiarlo, guardarlo in trasparenza magari soffiandoci sopra un po’ di vento trasversale. La boxe, potrebbe riempire una decina di numeri monografici del Foglio Sportivo perché è uno degli sport più letterari e più raccontati che esistano. Boxe sia, dunque, ma scegliendo due libri decisamente poco mainstream, due storie che squarciano il velo su uno sport bello e dannato.
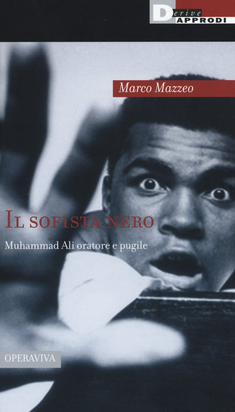 Il primo è Il Sofista nero di Marco Mazzeo (DeriveApprodi, 2017), il cui sottotitolo ci regala un indizio: Muhammad Alì, oratore e pugile. Mazzeo scrive una meravigliosa e coltissima biografia filosofica del più grande campione di tutti i tempi (The Greatest, appunto). Un atleta capace di cambiare un paradigma all’interno del suo sport (c’è una boxe prima e una dopo Muhammad Alì) e di migliorare anche un po’ il mondo. Quello fuori dal ring, intendo. Il cambio di paradigma che Mazzeo mette a fuoco è la capacità di Alì di portare la parola dentro la boxe, sport del pugno silente, attività nella quale, fino a quel momento, parlare era roba da deboli. L’eloquio, con Alì, diventa strumento di attacco: poesie (come quel “MeWe”, la più breve poesia mai composta, versi ispirati e recitati live davanti ai laureandi di Harvard), ma anche insulti, trash-talking, prese per i fondelli, profezie sul numero dei round che gli sarebbero serviti per mettere ko l’avversario. Le parole diventano cazzotti che fiaccano gli avversari prima ancora di salire sul ring e per dimostrarlo Mazzeo fa duettare dialetticamente Alì con Benjamin, Aristotele, Feuerbach. Se per il commentatore (pensate a un’icona del settore come Gay Telese) l’importanza della parola è scontata, per l’atleta quella scoperta capovolge un certo modo di stare al mondo. Il rapporto tradizionale tra i fattori è rovesciato, il paradigma è saltato: grazie al pugile di Louisville, la boxe diventa affare linguistico.
Il primo è Il Sofista nero di Marco Mazzeo (DeriveApprodi, 2017), il cui sottotitolo ci regala un indizio: Muhammad Alì, oratore e pugile. Mazzeo scrive una meravigliosa e coltissima biografia filosofica del più grande campione di tutti i tempi (The Greatest, appunto). Un atleta capace di cambiare un paradigma all’interno del suo sport (c’è una boxe prima e una dopo Muhammad Alì) e di migliorare anche un po’ il mondo. Quello fuori dal ring, intendo. Il cambio di paradigma che Mazzeo mette a fuoco è la capacità di Alì di portare la parola dentro la boxe, sport del pugno silente, attività nella quale, fino a quel momento, parlare era roba da deboli. L’eloquio, con Alì, diventa strumento di attacco: poesie (come quel “MeWe”, la più breve poesia mai composta, versi ispirati e recitati live davanti ai laureandi di Harvard), ma anche insulti, trash-talking, prese per i fondelli, profezie sul numero dei round che gli sarebbero serviti per mettere ko l’avversario. Le parole diventano cazzotti che fiaccano gli avversari prima ancora di salire sul ring e per dimostrarlo Mazzeo fa duettare dialetticamente Alì con Benjamin, Aristotele, Feuerbach. Se per il commentatore (pensate a un’icona del settore come Gay Telese) l’importanza della parola è scontata, per l’atleta quella scoperta capovolge un certo modo di stare al mondo. Il rapporto tradizionale tra i fattori è rovesciato, il paradigma è saltato: grazie al pugile di Louisville, la boxe diventa affare linguistico.
 Il secondo libro si intitola Arthur Cravan, Grande trampoliere smarrito a cura di Edgardo Franzosini (Adelphi, 2018). Se Muhammad Alì era il nome d’arte di Cassius Clay, Arthur Cravan era quello di Fabian Avenarius Lloyd, classe 1892. Anche lui pugile-poeta, un uomo di due metri di altezza, eccentrico precursore del Dadaismo. Il libro si divide in Scritti, Poesie e Lettere ed è assolutamente impossibile da descrivere. Bisogna trattenere il fiato ed entrare con la testa, il cuore, la pancia dentro a pagine che raccontano la tumultuosa vicenda umana di un uomo capace di illuminazioni folgoranti e che visse tutta la sua vita romanzesca, boxe inclusa, come un’opera d’arte. Lui, che si dichiarava cittadino di venti paesi, che sventagliava passaporti falsi come mazzi di carte per assecondare la sua irrequietezza e per sfuggire agli obblighi militari, si trovò nell’aprile del 1916 alle Isole Canarie dove riuscì a farsi organizzare un incontro con il campione del mondo Jack Johnson (uno il cui nome veniva usato dai soldati britannici per descrivere i grandi proiettili neri dell’artiglieria pesante tedesca) al fine di tirar su qualche dollaro e trasferirsi negli Stati Uniti. Finì al tappeto in un amen. Insomma, pugilisticamente parlando nulla a cui spartire con Muhammad Alì, ma se si fossero conosciuti si sarebbero senz’altro piaciuti. Quale anima si contenderà il mio corpo? si chiede Cravan in un suo struggente verso. Già, anime complicate quelle di Alì e di Cravan, difficili da racchiudere in un unico contenitore. Si ammalarono quelle anime, del dolore per un corpo che non smetteva più di tremare o di malinconia e istinti suicidi, come quella di Cravan che si imbarcò, per l’ennesimo viaggio, nel 1918 dal Messico verso l’Argentina. Lo videro per l’ultima volta al largo delle coste di Salina Cruz, poi mai più. Due pugili, due geni, due poeti. Due esseri umani che insegnarono al mondo che le parole possono essere dirompenti come un gancio sinistro.
Il secondo libro si intitola Arthur Cravan, Grande trampoliere smarrito a cura di Edgardo Franzosini (Adelphi, 2018). Se Muhammad Alì era il nome d’arte di Cassius Clay, Arthur Cravan era quello di Fabian Avenarius Lloyd, classe 1892. Anche lui pugile-poeta, un uomo di due metri di altezza, eccentrico precursore del Dadaismo. Il libro si divide in Scritti, Poesie e Lettere ed è assolutamente impossibile da descrivere. Bisogna trattenere il fiato ed entrare con la testa, il cuore, la pancia dentro a pagine che raccontano la tumultuosa vicenda umana di un uomo capace di illuminazioni folgoranti e che visse tutta la sua vita romanzesca, boxe inclusa, come un’opera d’arte. Lui, che si dichiarava cittadino di venti paesi, che sventagliava passaporti falsi come mazzi di carte per assecondare la sua irrequietezza e per sfuggire agli obblighi militari, si trovò nell’aprile del 1916 alle Isole Canarie dove riuscì a farsi organizzare un incontro con il campione del mondo Jack Johnson (uno il cui nome veniva usato dai soldati britannici per descrivere i grandi proiettili neri dell’artiglieria pesante tedesca) al fine di tirar su qualche dollaro e trasferirsi negli Stati Uniti. Finì al tappeto in un amen. Insomma, pugilisticamente parlando nulla a cui spartire con Muhammad Alì, ma se si fossero conosciuti si sarebbero senz’altro piaciuti. Quale anima si contenderà il mio corpo? si chiede Cravan in un suo struggente verso. Già, anime complicate quelle di Alì e di Cravan, difficili da racchiudere in un unico contenitore. Si ammalarono quelle anime, del dolore per un corpo che non smetteva più di tremare o di malinconia e istinti suicidi, come quella di Cravan che si imbarcò, per l’ennesimo viaggio, nel 1918 dal Messico verso l’Argentina. Lo videro per l’ultima volta al largo delle coste di Salina Cruz, poi mai più. Due pugili, due geni, due poeti. Due esseri umani che insegnarono al mondo che le parole possono essere dirompenti come un gancio sinistro.


Il Foglio sportivo - in corpore sano
Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo







