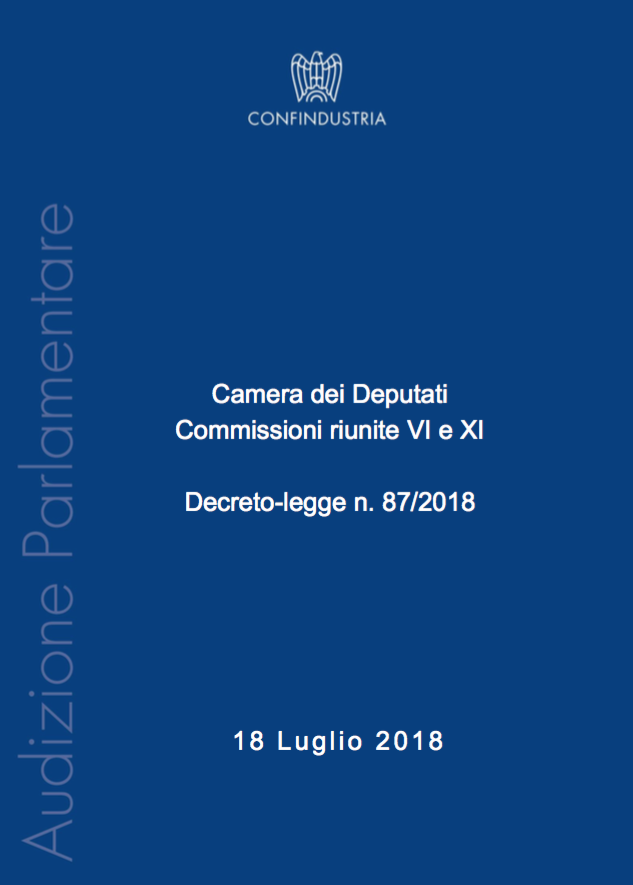Il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci (foto LaPresse)
Così il decreto dignità rallenterà la crescita
L'intervento del direttore generale di Confindustria Marcella Panucci durante la sua audizione in commissione Lavoro e Finanza alla Camera
Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,
Vi ringrazio per l’invito a questa audizione sul Decreto-legge n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), che costituisce il primo provvedimento di particolare impatto economico e sociale del nuovo Governo.
Questa occasione ci consente di condividere con Voi non soltanto una valutazione sulle singole misure, ma anche qualche riflessione più ampia sugli indirizzi di politica economica del nuovo Esecutivo.
Confindustria ha più volte evidenziato la necessità, per le imprese, di poter contare su un mercato del lavoro dinamico ed efficiente, soprattutto a beneficio dei giovani, nonché su un ambiente normativo e istituzionale favorevole agli investimenti, anche esteri.
Nel recente Patto per la fabbrica, sottoscritto con Cgil, Cisl, Uil, e in occasione delle nostre Assise generali di Verona abbiamo elaborato proposte concrete che vanno in questa direzione.
Il decreto in esame, pur perseguendo obiettivi condivisibili – tra cui il contrasto all’abuso dei contratti flessibili e alle delocalizzazioni selvagge – contiene misure e adotta strumenti che renderanno più incerto e imprevedibile il quadro delle regole in cui operano le imprese, disincentivando gli investimenti e limitando la crescita.
Mi riferisco, in particolare, al superamento di alcune innovazioni contenute nel Jobs Act, che hanno contribuito al miglioramento del mercato del lavoro, nonché all’introduzione di regole poco chiare e punitive in materia di delocalizzazioni.
Rimaniamo convinti che occorrerebbe evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati, assicurare stabilità e certezza al quadro regolatorio e non alimentare aspettative negative da parte degli operatori economici.
Pertanto, a nostro giudizio l’esame parlamentare del Decreto Dignità può e deve rappresentare l’occasione per approvare alcuni correttivi volti a garantire una crescita sostenibile e inclusiva del Paese, che favorisca la competitività delle imprese e valorizzi il lavoro.
Di seguito alcune considerazioni sul dettaglio delle singole misure.
A) Misure in materia di lavoro
1. Contratti a termine
Il provvedimento rende più difficoltoso il ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione.
Infatti, attraverso alcune significative modifiche alla normativa vigente, il Decreto Dignità:
• riduce da 36 a 24 mesi la durata massima dei contratti a termine e reintroduce le causali (per i contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi), costringendo le imprese, attraverso formulazioni lessicali più o meno dettagliate, a “giustificare” il ricorso ai contratti a termine ed esponendole così all’imprevedibilità del contenzioso giudiziale;
• riduce le proroghe da 5 a 4 (nei primi 12 mesi di rapporto sono libere);
• prevede l’incremento dello 0,50% del contributo previdenziale addizionale (a carico del datore di lavoro), in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine;
• aumenta il termine (da 120 a 180 giorni) entro cui è possibile impugnare il contratto a termine;
• in tema di somministrazione, estende i limiti (di durata e di disciplina) previsti per il contratto a tempo determinato ai contratti di lavoro a termine che le agenzie per il lavoro stipuleranno con i singoli lavoratori da inviare in missione presso le imprese utilizzatrici.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle nuove misure i contratti stagionali che, quindi, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali. Inoltre, l’applicazione delle nuove norme riguarda i contratti a termine stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (nonché le proroghe e i rinnovi relativi ai contratti in corso). Rispetto alle prime bozze del provvedimento, si tratta di due correttivi condivisibili, che recepiscono sollecitazioni provenienti anche da Confindustria.
In sostanza, il decreto-legge individua nel contratto a tempo determinato e nella somministrazione gli strumenti contrattuali cui andrebbe imputata la cd. precarizzazione dei rapporti di lavoro. Da qui la scelta di imporre una “stretta” alla disciplina vigente, con tanto di retromarcia, come anticipato in premessa, rispetto a scelte compiute solo pochi anni fa.
I dati, tuttavia, non sembrano supportare questa conclusione.
In primo luogo, vi sono molteplici fattori, sia economici sia normativi, che verosimilmente spiegano una larga parte dell’aumento del lavoro temporaneo osservato negli scorsi anni:
• anzitutto, dal 2014 (anno di entrata in vigore del cd. Decreto Poletti), è in atto in Italia un aumento fisiologico della quota di lavoro a tempo determinato, legato alla fase di ripresa del ciclo economico, peraltro in linea con quanto sta accadendo in Francia e in Spagna;
• inoltre, alla natura ciclica dell’aumento del lavoro temporaneo si aggiunge un ulteriore fattore economico, ovvero la variazione della composizione settoriale, alla quale, secondo stime AREL, sarebbe imputabile oltre un quinto dell’aumento dei dipendenti a termine osservato nel periodo 2014- 2017: ciò implica che degli oltre 500mila dipendenti a termine osservati in più, almeno 100mila sono attribuibili all’aumento del peso dei servizi, e tra questi in particolare turismo, commercio e servizi alla persona;
• il recente aumento dell’occupazione temporanea deve essere letto altresì alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di lavoro negli ultimi anni, ovvero l’abrogazione dei contratti di collaborazione a progetto e del lavoro accessorio regolato tramite voucher. La sola abolizione dei voucher sembrerebbe spiegare una quota consistente, attorno al 15%, dell’aumento del lavoro a termine intervenuto dal 2° trimestre 2017.
I dati non sembrano quindi supportare la preoccupazione di un aumento della precarietà del lavoro legata a comportamenti opportunistici da parte delle imprese. Al contrario, la quota di aumento del lavoro temporaneo spiegato dalla corrispondente riduzione di collaborazioni e lavoro accessorio è verosimilmente associata a una diminuzione della precarietà, anziché al temuto aumento.
In secondo luogo, ulteriori dati mostrano che il Decreto Poletti ha raggiunto l’auspicato obiettivo di promuovere la successiva “stabilizzazione” del rapporto di lavoro, attraverso la maggiore facilità di ricorso al contratto a tempo determinato, unita a un’estensione della sua durata massima.
L’idea di fondo era che il protrarsi nel tempo della collaborazione lavorativa avrebbe favorito la consapevolezza dell’opportunità, per il datore di lavoro, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro.
Questa idea sembra aver trovato riscontro concreto: infatti, i dati contenuti nel Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2018 del Ministero del Lavoro evidenziano, a partire dal 2015, un aumento dell’incidenza delle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi, quota che si attesta al 25,7% nel 2017.
In terzo luogo, il confronto internazionale mostra che l’incidenza del lavoro temporaneo in Italia (16,4% del totale dell’occupazione dipendente nel primo trimestre 2018) è in linea con il dato medio dell’Eurozona (16,3%), come lo è anche il tasso di transizione a 12 mesi dai contratti a termine ai contratti a tempo indeterminato (pari a circa il 20%). A quest’ultimo riguardo, è pur vero che il tasso di transizione è più basso che in passato (era quasi il 30% nell’immediato pre-crisi) e al di sotto di quello tedesco (30,3%).
I dati, dunque, non appaiono corroborare quei “fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo” che le modifiche contenute nel Decreto Dignità intendono contrastare.
Va invece sottolineato come tali modifiche rischiano di avere un impatto negativo sull’occupazione complessiva, considerato anche che il ritorno delle causali comporterà un aumento del contenzioso, che le riforme degli anni scorsi avevano contribuito ad abbattere (le cause di lavoro sui contratti a termine sono passate da oltre 8.000 nel 2012 a 1.250 nel 2016).
Peraltro, il fatto che per contratti tra i 12 e i 24 mesi sia richiesto alle imprese di indicare le condizioni del prolungamento, esponendole all’imprevedibilità di un’eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull’occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al Decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi).
Pertanto, a nostro giudizio è necessario modificare le misure contenute nel decreto-legge sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro.
In proposito, occorre ricordare che la normativa europea (direttiva 1999/70/CE) riconosce espressamente che i contratti a tempo determinato soddisfano, in alcune circostanze, sia le esigenze dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro.
Ed infatti, la citata direttiva – anche in base alle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia – afferma che per prevenire l’abuso della successione di contratti a termine è sufficiente adottare una misura tra le tre suggerite, che sono: i) causali; ii) durata massima totale dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore; iii) limite al numero dei rinnovi.
A seguito dell’approvazione del decreto-legge in esame, il nostro ordinamento ha previsto tutte le misure “limitative” consentite dalla normativa europea, ossia la previsione di causali, il limite di durata massima dei rapporti (24 mesi) e un limite al numero massimo di rinnovi pari a 4.
Se s’intende accelerare la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, è sufficiente ridurre la durata massima dei contratti a 24 mesi, intervenendo eventualmente in riduzione anche sul numero massimo delle proroghe.
In questo senso, la proposta che Confindustria sottopone al Parlamento è di:
• prevedere che l’apposizione di un termine massimo di 24 mesi per la durata del contratto a termine non sia subordinata all’individuazione di causali;
• modificare le misure dedicate alla somministrazione in coerenza con la scelta - condivisibile - di escludere i contratti a termine “serventi” il contratto di somministrazione dalle limitazioni derivanti dalle norme sul diritto di precedenza e dai limiti numerici fissati dalla legge; dando seguito a questa opzione, occorre esonerare il contratto a tempo determinato tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore dall’indicazione delle causali, nonché dalla disciplina degli intervalli temporali tra la stipulazione di un contratto a tempo determinato e il successivo (art. 21, co. 2, d. lgs. n. 81/2015);
• chiarire la natura non incrementale dell'aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, evitando così un incremento irragionevole e sproporzionato dei costi a carico dei datori di lavoro.
2. Licenziamenti
Il provvedimento in esame innalza del 50% le indennità dovute in caso di licenziamento illegittimo, finendo per ridurre la convenienza relativa del contratto a tempo indeterminato che, invece, si vorrebbe promuovere con le restrizioni sul lavoro a tempo determinato.
Al riguardo, si osserva che l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo previsto dal Jobs Act era già maggiore di quanto previsto in altri paesi: quello minimo (4 mesi) è quadruplo rispetto a quello di Francia, Germania e Spagna; mentre l’indennizzo massimo (24 mesi) è superiore a quelli di Francia (20 mesi) e Germania (18 mesi).
Pertanto, l’ulteriore aumento delle mensilità dovute, oltre a non trovare riscontro sul piano comparato, rischia di scoraggiare anche le assunzioni a tempo indeterminato.
B) Misure anti-delocalizzazioni
Il Decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: una di portata generale riguardo alle delocalizzazioni da parte di imprese beneficiarie di aiuti (art. 5); un’altra dedicata alla tutela occupazionale (art. 6) e le altre due ai temi specifici dell'iperammortamento (art. 7) e del credito d'imposta ricerca (art. 8).
Rispetto alle prime formulazioni, il Decreto ha recepito alcuni correttivi, sollecitati anche da Confindustria, che ne riducono, sebbene solo in parte, i potenziali impatti negativi sul tessuto produttivo.
In particolare, con riferimento agli articoli 5 e 6, è stata esclusa l’applicazione delle nuove norme ai benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati, ed è stato ridotto il vincolo temporale di mantenimento delle attività oggetto di beneficio da 10 a 5 anni.
Tuttavia, la disciplina introdotta dal Decreto presenta evidenti difficoltà di applicazione pratica, rimessa peraltro alle singole amministrazioni erogatrici, anche perché non individua una definizione chiara della delocalizzazione “rilevante”, e rende la disciplina in materia molto più estesa e punitiva di quella pre-vigente, anche perché contempla una sanzione aggiuntiva alla restituzione dell’aiuto percepito (fino a 4 volte tale importo per le delocalizzazioni verso Stati non UE e non aderenti allo Spazio Economico Europeo).
Inoltre, riguardo ai profili di applicazione temporale delle misure, non è chiaro il momento a partire dal quale decorre il termine per il calcolo dei 5 anni di mantenimento in Italia dell’attività agevolata. Infatti, si fa riferimento “alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata” (art. 5), ovvero “alla data di completamento dell’investimento” (art. 6), condizioni non sempre identificabili in modo agevole, in ragione delle differenti tipologie di aiuto concesse.
In aggiunta alle pur evidenti difficoltà interpretative e applicative, rileva poi una considerazione di portata generale.
A giudizio di Confindustria, alla delocalizzazione non può essere associata una connotazione necessariamente negativa e occorre distinguere i processi di internazionalizzazione dell’attività d’impresa dalle delocalizzazioni selvagge.
Esiste, infatti, un forte legame tra l’articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale. La creazione di catene della produzione su base europea o globale tende a migliorare la performance economica, anche in virtù di un processo di learning by offshoring, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l’accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva.
Il passaggio verso forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sull’occupazione e sul valore aggiunto delle imprese che le realizzano, con un notevole miglioramento della produttività. In particolare, le multinazionali estere contribuiscono in modo significativo all’interscambio commerciale italiano, realizzando oltre un quarto delle esportazioni nazionali di merci (26,1%).
Pertanto, la logica di tutela nell’utilizzo delle risorse pubbliche – che è alla base del provvedimento – andrebbe perseguita contemplando la possibilità di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dalle risorse medesime, evitando atteggiamenti pregiudizievoli e punitivi verso le scelte imprenditoriali.
Alla luce di queste considerazioni, Confindustria ritiene necessaria l’adozione in sede parlamentare di correttivi che, senza stravolgere la ratio di fondo del provvedimento, consentano di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che invece vanno salvaguardate. L’obiettivo dovrebbe essere di focalizzare le nuove misure sui soli casi di utilizzo scorretto dei fondi pubblici che si traduca nella distrazione di base produttiva e occupazionale dal nostro Paese.
In questo senso, occorre quindi:
• chiarire che la delocalizzazione rilevante per la restituzione dei benefici debba riguardare in modo specifico l’attività/investimento produttivo o il bene agevolato e non la complessiva attività economica dell’impresa. In altri termini, occorre vi sia una perfetta coincidenza tra attività/investimento o bene agevolati e quelli oggetto di delocalizzazione. Ciò è tanto più rilevante rispetto alla fattispecie di aiuti specificamente localizzati sul territorio (es. quelli per gli investimenti nel Mezzogiorno), di cui si prevede la decadenza se anche una parte dell’attività economica è trasferito fuori dal territorio interessato, anche in ambito nazionale, estendendo i vincoli già previsti a carico delle imprese e con il rischio di limitare l’attrazione di investimenti in quelle aree;
• superare un approccio eccessivamente punitivo, che renderebbe il nostro Paese poco attrattivo anche nei confronti degli investitori esteri. A tal fine, andrebbe attenuato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni extra UE, secondo cui, oltre alla restituzione dell’agevolazione, si applica anche una sanzione amministrativa, evidentemente sproporzionata, da due a quattro volte l’importo del beneficio erogato;
• escludere espressamente dal perimetro applicativo delle nuove norme gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riguardo a quelle concesse alle PMI. Tali aiuti, infatti, sono volti a sostenere l’accesso al credito ordinario da parte delle piccole e medie imprese, consentendo loro di superare le tradizionali difficoltà di dialogo con il sistema finanziario. L’introduzione di nuove e stringenti limitazioni potrebbe determinare, rispetto a questa specifica categoria di agevolazioni, difficoltà correlate alla gestione dell’operazione garantita, ostacolando l’accesso delle PMI al credito bancario per investimenti;
• riguardo alla tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, chiarire l’ambito di applicazione della misura, anche attraverso una più chiara definizione dei “casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo” che escludono la revoca degli incentivi concessi.
Inoltre, si segnala che rientrano nel capitolo delocalizzazioni anche alcune disposizioni dedicate al recupero del beneficio fiscale dell’iperammortamento, applicabili qualora, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolabili siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive estere, anche appartenenti alla medesima impresa (senza alcuna distinzione dei paesi di destinazione tra Stati extra UE e Stati UE o SEE).
Sul punto, si segnala che la norma penalizza le imprese italiane che operano tramite stabili organizzazioni all’estero. Le stabili organizzazioni, in conformità alla normativa internazionale, costituiscono diramazioni delle imprese italiane (es. succursali, uffici, laboratori, miniere, cantieri, etc.) e, pertanto, l’utilizzo all’estero di beni agevolati non determina una delocalizzazione, ma contribuisce alla creazione di ricchezza in capo alla società italiana destinata, in ultima analisi, ad essere tassata in Italia (tali considerazioni non si applicano, ovviamente, ai casi di imprese in regime di branch exemption, per le quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le previsioni sul recupero).
Inoltre, condivisibilmente, la nuova previsione non ha efficacia retroattiva e si applica agli investimenti “effettuati” dopo l’entrata in vigore del Decreto; tuttavia, occorre un intervento correttivo che salvaguardi gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano stati già finalizzati ordini accettati dal venditore, con versamento di acconti sul prezzo. In altri termini, poiché ai fini dell’agevolazione gli investimenti si considerano “effettuati” alla data della consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà, il mero richiamo all’effettuazione dell’investimento rischia di penalizzare quelli concretamente avviati prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Pertanto, sono necessari alcuni correttivi volti a escludere dall’applicazione della norma relativa all’iperammortamento:
• gli investimenti destinati a stabili organizzazioni all’estero di imprese italiane, quanto meno nei casi in cui l’impresa non abbia esercitato l’opzione per il regime di branch exemption;
• gli investimenti già avviati (con effettuazione di un ordine, accettato dal venditore, e versamento di un acconto) ma non ancora completati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.
C) Misure di contrasto alla ludopatia
Il Decreto vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Dal 1° gennaio 2019, tale divieto è esteso anche alle sponsorizzazioni.
Pur consapevoli della delicatezza del tema, evidenziamo come il gioco legale sia un'attività lecita, che può creare dipendenza solo in caso di abuso ed è proprio per scongiurare questo rischio che il quadro regolatorio nazionale conteneva già delle previsione restrittive.
Intervenire oggi con un divieto assoluto rischia di: i) limitare in modo sproporzionato l’attività degli operatori del settore gioco; ii) punire il gioco legale non compulsivo, senza risolvere comunque il fenomeno della ludopatia; iii) aumentare il fenomeno del gioco illegale.
Peraltro, il divieto assoluto introdotto dal decreto rappresenta un caso isolato in Europa e va oltre gli orientamenti comunitari, che prevedono già una regolamentazione puntuale della materia, circoscrivendo e definendo i divieti per specifici prodotti di gioco o per determinate fasce orarie e/o programmi.
Per tali ragioni, occorrerebbe quindi modificare la norma, escludendo il divieto assoluto di pubblicità e prevedendo invece ulteriori strumenti volti a rendere più severa l’attuale disciplina e a qualificare ulteriormente la pubblicità.
Infatti, nonostante il quadro regolatorio sia già restrittivo, esistono i margini per interventi che incidano su temi come la durata degli spot, i tempi della loro programmazione, ma anche sugli stessi contenuti. In questo contesto, tra le proposte avanzate dagli operatori del settore, si richiamano quelle volte a evitare il sovraffollamento degli spot dedicati al gioco nei singoli blocchi pubblicitari e a sottoporre ogni campagna di comunicazione alla valutazione preventiva di soggetti od organismi autonomi.
Va salvaguardato il valore della pubblicità, che ha una tradizionale valenza positiva sul piano informativo e può essere ulteriormente orientata a qualificare il settore del gioco e a formare il pubblico, per renderlo maggiormente consapevole dei rischi derivanti da un uso eccessivo.
In parallelo, si potrebbe intervenire direttamente sul gioco, rafforzando i controlli e investendo sulla formazione degli operatori, anche nell’ottica di una revisione complessiva della normativa che regola il settore, orientata, tra gli altri, a obiettivi di qualificazione e sicurezza della filiera del gioco legale.
D) Misure di semplificazione fiscale
Le norme in materia di redditometro, split payment e spesometro, hanno apportato alcune semplificazioni, seppur di ridotto impatto per le imprese.
In particolare, con riguardo allo split payment il Decreto esclude da questo meccanismo di corresponsione dell’IVA solo i lavoratori autonomi e non si occupa delle imprese.
Anche in questa sede, tuttavia, ci preme segnalare che il sistema di fatturazione elettronica obbligatorio e generalizzato tra privati ridurrà significativamente il rischio di frodi fiscali. L’immediata disponibilità dei dati, infatti, agevolerà il controllo e consentirà di accelerare le procedure di verifica e le ispezioni da parte dell’Amministrazione finanziaria; pertanto, alla luce del prossimo assetto di fatturazione elettronica generalizzata non si ritengono più giustificati i due strumenti antifrode - split payment e reverse charge - introdotti negli anni passati al fine di contrastare l’evasione fiscale IVA. Si tratta di procedure che gravano significativamente sulle imprese, sia a causa della costante incertezza sul perimetro oggettivo di applicazione e, di conseguenza, in ragione delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione, sia per la significativa esposizione finanziaria che, in special modo lo split payment, genera in capo alle imprese fornitrici di beni e servizi.
Pertanto, sarebbe necessario estendere sin da subito l’esclusione dallo split payment anche alle imprese e valutare una completa rivisitazione del regime sanzionatorio IVA e del meccanismo del reverse charge.
In conclusione, non posso che ribadire l’auspicio che il dibattito parlamentare rappresenti l’occasione per una riflessione approfondita, che conduca all’approvazione di quei correttivi indispensabili per scongiurare effetti pregiudizievoli del provvedimento sull’economia, salvaguardandone gli obiettivi di fondo.